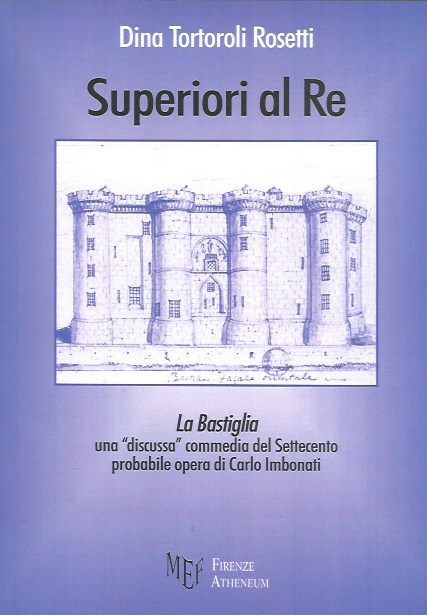DINA TORTOROLI
L’utilizzo coscienzioso delle parole e la loro ragionevole interpretazione sono di vitale importanza e il “caso-Armfelt” lo dimostra.
È una vicenda “più svedese che italiana”, ma Francesco Piranesi (in quanto console svedese per i Porti dello Stato Pontificio) vi si era “trovato coinvolto”, essendo stato incaricato di sorvegliare l’Armfelt, in Italia come ministro svedese, sospettato di tradimento.
L’affaire ha origine dall’interpretazione, volutamente distorta dal ministro Acton, dell’espressione SE SAISIR, utilizzata come pretesto per non ottemperare alle richieste della Svezia.
«I precisi termini della richiesta di S. M. svedese – leggiamo nella Lettera di Francesco Piranesi al Signor Generale D. Giovanni Acton – erano questi: “Aspetto adunque dai sentimenti d’amicizia di V.M. ch’ella si degni di dare i suoi ordini, perché la persona incaricata di SE SAISIR del baron d’Armfeldt egualmente che di tute le sue carte…, possa adempire la sua commissione con quella segretezza, che in simili casi è pur necessaria”». Ma – prosegue l’autore – «l’ingenuità del gabinetto di S. Gennaro stacca quel se saisir dalla preghiera che lo precede, e sfigurando il senso puro e innocente di questo termine, vi ravvisa dentro un manifesto insulto alla sua corona».
John Acton, infatti, disse che «la corte di Svezia dimandò a quella di Napoli di lasciare al baron di Palmquist SE SAISIR del baron d’Armfelt”», vale a dire che il Ministro del Re «volle far credere che la Svezia chiedesse la libertà di poter commettere in casa di S. M. siciliana un atto d’indipendenza e di prepotenza».
L’autore – io dico Carlo Imbonati – lo apostrofa così: «Che bizzarra pretensione, che maligno partito è mai questo di volere a viva forza che uno scritto s’interpreti a modo vostro, e non secondo il senso comune, e che si debba rovesciare l’intrinseca natura delle parole, perché voi abbiate ragione?» (Lettera, pp. 45 e 102).
Un memorabile episodio della vita di Ugo Foscolo mi induce a credere che con quelle stesse parole Carlo Imbonati avrebbe potuto redarguire l’inattendibile “patriota”, reo di un analogo misfatto.
Mi riferisco al suo “infelice incontro” con Giulia Beccaria e Alessandro Manzoni, “ai primi di marzo 1806”.
Guido Bezzola gli dedica due pagine del saggio Giulia Manzoni Beccaria, e io mi avvalgo delle sue informazioni e delle sue considerazioni più ragguardevoli:
«Di passaggio a Parigi dopo il suo soggiorno con le truppe italiane sulla costa atlantica, Foscolo si recò a trovare i Manzoni e fu ricevuto a dir poco assai freddamente sia dalla madre sia dal figlio. Perché? Le ragioni di moralità non sarebbero valse a molto per Giulia, la quale non poteva di sicuro rimproverare al Foscolo la relazione con la Fagnani Arese, d’altronde chiusa; vedere nel Foscolo il demone tentatore del gioco d’azzardo che per qualche tempo affascinò Alessandro aveva poco senso ora che Milano era stata lasciata forse per sempre. Mi è capitato altrove* di esprimere un’ipotesi (nulla più di un’ipotesi) secondo la quale Giulia e Alessandro si sarebbero offesi per i disinvolti prelievi operati dal Foscolo, come era suo costume**, dall’ode manzoniana Qual su le Cinzie cime in pro di All’amica risanata. Giulia, gelosa custode della nascente gloria del figlio, avrebbe potuto benissimo risentirsene, come fece, e il Foscolo e il Manzoni non si incontrarono più benché, quasi ad ammenda, in una nota ai Sepolcri (1807) il Foscolo citasse i versi dell’Imbonati relativi ad Omero, aggiungendo: “Poesia di un giovane ingegno nato alle lettere e caldo d’amor patrio: la trascrivo per tutta lode, e per mostrargli quanta memoria serbi di lui il suo lontano amico”. L’unico accenno esplicito alla vicenda ci viene ancora dal Foscolo che scrivendo il 3 febbraio 1816 da Hottingen a Sigismondo Trechi diceva: “Da Manzoni desidero d’essere stimato; non altro: e il perché di questo non altro mi sta scritto nel cuore da più e più anni, e sino da che ci siamo veduti in Parigi; tuttavia m’è bastato lasciargli il rimorso della sua poca costanza in amare gli amici; ho perdonato alla gioventù dell’età, alla debolezza del carattere e alle pazzie di sua madre la freddezza con che accolse la mia visita; né riconobbe in me l’uomo che avea, per così dire, riscaldato l’ingegno di quel giovane nel proprio seno…”. Le “pazzie di sua madre” mi paiono, pur nella loro ambiguità, sufficientemente esplicite: il Foscolo attribuiva le cause di quella fredda se non ostile accoglienza proprio a Giulia Beccaria, che il figlio seguiva fedelmente. Una volta accettato codesto punto, sarà difficile scorgervi motivi diversi dai letterari, dato che la conversione del Manzoni era ancora di là da venire: sta di fatto che allora l’amicizia finì e che in seguito i giudizi del Manzoni sul Foscolo furono piuttosto severi» ( G. Bezzola, Giulia Manzoni Beccaria, Rusconi, Milano, 1985, pp. 136-137).
I lettori di Margutte, che hanno visto Giulia e Alessandro – in quello stesso anno 1806 – comportarsi come “due sacripanti”, nei confronti di Giambattista Pagani, reo di avere aggiunto di propria iniziativa una dedica a Vincenzo Monti dei Versi in morte di Carlo Imbonati, di cui aveva il compito di curare la ristampa, a Milano (puntata n.16), certamente non sono stati colti alla sprovvista dall’ipotesi espressa dal professor Bezzola, ma probabilmente vorrebbero sapere perché “i due pazzerelli” avessero poi ritenuta opportuna la riconciliazione soltanto con Pagani.
Io avanzo l’unica spiegazione che mi pare attendibile, dopo aver letto personalmente la sezione IX dell’“Esame” del Foscolo “su le accuse contro Vincenzo Monti”, che avevo soltanto sentito declamare nel lontanissimo 1955, a scuola, da un insegnante infatuato, e di cui ricordavo soltanto l’enfatico incipit: « Ma si sveli finalmente nel Monti l’autore della lettera pubblicata sotto il nome di Francesco Piranesi».
Penso che il professore non avesse mai letta la Lettera in questione, perché avrebbe dovuto dire che Foscolo ne travisa il contenuto e quindi lo scopo, manipolandone le parole***.
Esordisce, parlando di “reggia”, anziché di “corte”, poi introduce l’ambigua espressione “despota siciliano”, senza mai nominare John Acton né accennare minimamente ai capi d’accusa da cui il fedifrago ministro viene tempestato: di “aver negata la verità conosciuta e sostituita la menzogna, la cabala, l’impostura”; “avere ingannata lungamente l’Europa, e stancata la pubblica sofferenza”; “avere calpestate le leggi tutte, umane e divine, col farsi artefice delle calunnie più scandalose”; “avere oppressa l’innocenza per giustificare il delitto”; insomma, di “aver tradita per mille versi la religione, l’onore e la gloria del suo Principe”.
Infine, Foscolo afferma che il Monti, per aver pubblicato “verità” che “minacciavano l’onnipotenza dei Troni”, avrebbe potuto essere considerato “quasi calunniator de’ Sovrani”: un’assurdità, considerando il “coraggio” – per quanto “rispettoso” – con cui l’autore induce il “generoso e benefico Ferdinando Quarto” a valutare i modi in cui il Ministro gli funestava quotidianamente lo spirito: le “politiche malinconie, che propagano nell’animo il terrore, la diffidenza e il sospetto, ed alzavano fra lui e il suo popolo un muro di divisione”.
Per la salvezza della monarchia, l’autore della Lettera osa addirittura chiedere al Re di “ritirare la mano” con cui sosteneva il suo “superbo e maligno” Ministro.
Sono parole che riecheggiano l’invocazione di Mirabeau a Luigi XVI, il nuovo sovrano di Francia, che aveva suscitato tante speranze:
rrachez-nous aux extorsions de cette cohorte avide, qui, depuis si longtemps, détruit vos richesses, en ruinant et désolant votre peuple. Rendez à votre peuple la liberté de travailler gaiement pour vous, de recueillir en paix les richesses de ce territoir fécond» (Strappateci alle estorsioni di questa corte avida, che, da così tanto tempo, distrugge le vostre ricchezze, rovinando e desolando il vostro popolo. Restituite al vostro popolo la libertà di lavorare lietamente per voi, di raccogliere in pace le ricchezze di questo territorio fecondo) (Mémoires sur les salines de la Franche-Comté, passo pubblicato da A. Vermorel, Mirabeau, I, Paris, 1879, pp. 120-121).
La Lettera vuole dunque essere un contributo alla lotta contro il dispotismo ministeriale.
In Francia, lo aveva preconizzato Helvétius, senza mezzi termini: «Un Re si crea degli ordini intermedi: questi ben presto saranno i suoi padroni e i tiranni del suo popolo».
Il sistema giudiziario ne era l’aspetto più plateale ed angosciante, e Gabriel Mirabeau ne era stato la vittima più bersagliata, ma anche la più ardimentosa nel combatterlo.
Nella commedia massonica La Bastiglia, in cui si intravede in filigrana la situazione di Mirabeau, Carlo Imbonati ne aveva rivelato a più riprese la “crudeltà inumana”, e vale la pena di rileggere le parole con cui Eugenia, l’eroica amante del protagonista Roberto, esprime lo sgomento dei sudditi: «Sol pensando a Roberto, io cercai / Di parlare al Ministro, onde ottenere / La sua liberazion mercè il mio pianto. / L’Albergatrice, a cui narrati avea / I casi miei, mi diè consiglj, e ajuti, / Onde poter parlar, perché a Parigi / Difficilmente si può aver la sorte / Di poter far sentir la voce al Trono / […] Nella mia stanza meditava il modo / Di poter presentarmi al pio Sovrano, / E gittarmi a’ suoi Piedi, e fargli note / Le mie disgrazie, e del crudel Ministro/ Svelargli l’operar. Ma quanti dubbj, / Quante difficoltà mi si affollavano! Per ottener tal grazia fa mestieri / Dipender da qualcun fra me dicea» (Atto III, Scena VI).
Diventa quindi doveroso valutate scrupolosamente, a una a una, le parole con cui lo scopo della missiva è ribadito al Re: «io desidero a questo scritto la sorte di poter penetrare in tutta la sua estensione (corsivo mio) a’ piedi del vostro trono, a cui è tempo che la verità si presenti per vendicare la vostra gloria e castigar l’impostura» (Lettera, p. 204).
Non è davvero credibile che Ugo Foscolo avesse potuto fraintendere le intenzioni dello scrivente, chiunque egli fosse; pertanto, è automatico immaginare lo sdegno e il dolore dell’Imbonati, le sue tormentose riflessioni e i reiterati ragionamenti affrontati insieme con Giulia Beccaria, che nel 1798 viveva con lui, a Parigi.
Memore di quella sofferenza, nel 1806, vedendosi davanti colui che l’aveva inflitta al “venerato” compagno, di cui lei piangeva da un anno la morte, Giulia non avrà saputo né voluto contenere il proprio disgusto, fino a giungere “al limite dell’ostilità”.
Chi oserebbe biasimarla?
E certamente non per una specie di “pazzia” l’esacerbata Giulia pretese che Alessandro non avesse più alcun rapporto con l’inaffidabile Foscolo; per immedesimarsi nel suo stato d’animo bisognerebbe almeno avere una visione unitaria dei problemi che affaticarono il “suo” Carlo, durante la stesura dell’incomparabile Lettera.
Invece, possiamo soltanto cercare di individuarli a uno a uno.
Cominciamo quindi col riconoscere la chiave di lettura dell’intero testo, che Carlo Imbonati volle offrire ai suoi “cari” lettori già nei primi due paragrafi:
«Voi dormite tranquillo, Signor Generale, sopra i vostri allori marittimi, e sul timone della nave di cui sedete al governo, e tutt’altro vi sognate sicuramente, che di ricevere una mia lettera. Perché son io costretto di servirvela? Qual linguaggio, qual formolario userò io con voi, io consagrato al servigio d’un principe ingiustamente offeso dal vostro? E quale sarà il galateo che adopererò se, nel mentre ch’io parlo, la Svezia da voi provocata prepara i suoi vascelli per portarvi a Napoli le sue ragioni sulla bocca eloquente de’ suoi cannoni?
Frattanto egli m’è necessario di scrivervi, e voi siete quello, che mi forzate. Se voi non aveste attaccata, che in privato la mia persona, se aveste ancora ciò fatto in Napoli al cospetto solamente de’ vostri schiavi, io vi avrei lasciato senza commovermi, eternamente latrare e mentire. Ma voi mi avete oltraggiato alla presenza del pubblico: voi mi avete atrocemente calunniato… ».
Sì: per quanto possa sorprendere, la Lettera “a nome” dell’artista romano Francesco Piranesi, calunniato dal Generale John Acton, potente Ministro del Re di Napoli, inizia proprio così, riproponendo la celeberrima apostrofe rivolta da Jean Jacques Rousseau all’Arcivescovo di Parigi, monsignor Christophe de Beaumont:
«Pourquoi faut-il, monseigneur, que j’aie quelque chose à vous dire? Quelle langue commune pouvons-nous parler? comment pouvons-nous nous entendre? et qu’y a-t-il entre vous et moi?
Cependant il faut vous répondre; c’est vous-même qui m’y forcez. Si vous n’eussiez attaqué que mon livre, je vous aurois laissé dire: mais vous attaquez aussi ma personne…»****
———
*G. Bezzola, Ancora sul testo dell’ode manzoniana “Qual su le Cinzie cime”, in : “Studi e problemi di critica testuale”, n. 16 (aprile 1978), p. 135.
**Afferma Isabella Teotochi Albrizzi (Ritratti, “Ugo Foscolo”, Sellerio editore Palermo, 1992, p. 121): «La sua vasta memoria è cera nel ricevere, marmo nel ritenere».
***Per agevolare l’eventuale verifica personale dei lettori, trascrivo sia il testo del Foscolo sia il brano della Lettera che lo smentisce nella maniera più clamorosa:
1) «Ma si sveli finalmente nel Monti l’autore della lettera pubblicata sotto il nome di Francesco Piranesi, ove non la immaginazione, ma lo intelletto e la storia hanno denunziato alla Europa quanto vi era di più infame nella reggia di Napoli. Allo stesso governo di Roma, mortale nemico di quella corte, spiacquero le audaci verità e le liberissime massime altamente propagate in quest’opera, poiché le accuse apposte al despota siciliano poteano agevolmente ed a diritto ritorcersi contro tutti i despoti di que’ tempi. Ché, se l’oro profuso da Acton per tracciare l’origine di tale scritto ne avesse scoperto l’autore verace, certo che la politica profondamente perfida del pontefice, per non isfidare ad aperta guerra il Re confinante, avrebbe punito il Monti quasi calunniator de’ sovrani, o trasmessolo a scontar col suo capo le verità che minacciavano la onnipotenza dei troni. Ponderate severamente le colpe tutte del Monti, questa lettera basta a controbilanciarle» (Foscolo, Esame…, IX, già fatto conoscere nella puntata n. 42)
2) «Generoso e benefico Ferdinando Quarto, ascoltate la voce di un uomo che la perfidia del vostro ministro vi ha descritto per assassino, ma d’un uomo che teme Iddio, che rispetta i monarchi e riconosce le vostre virtù. Ascoltatela questa voce, ch’ella è tutta di verità e voi siete degno d’udirla. Non cercate i vostri nemici nei bravi e giusti svedesi, che dimandano la riparazione di un gravissimo affronto da voi ricevuto. I vostri nemici son quelli che vi hanno indotto a commetterlo e a provocare lo sdegno d’una forte e coraggiosa nazione che non è mai stata impunemente oltraggiata. […]. I vostri nemici son quelli che nell’augusto e sacro nome perseguitano gl’innocenti, e li fanno gemere e spirare fra le catene in sembianza di scellerati. I vostri nemici sono quelli che funestandovi tutto giorno lo spirito con politiche malinconie, propagano nell’animo il terrore, la diffidenza e il sospetto, ed alzano fra voi ed il vostro popolo un muro di divisione, quando voi non siete fatto che per amarlo, ed egli per adorarvi. Finalmente i crudeli e forsennati vostri nemici son quelli che separano l’interesse del principato da quello del suddito, che bandiscono dal trono la verità, che affogano i gridi della miseria da lor cagionata, e incolpano di ribellione le giuste querele degli infelici, e vestono la tirannia colle sante ed immacolate divise della giustizia. Tali erano i Seiani e i Pallanti, e tant’altri mostri famosi che sono stati la ruina dei prìncipi, il flagello dei sudditi e l’esecrazione della posterità. Se il vostro ministro sìasi erudito alla scuola di queste fiere, o a quella dei Sully, dei Colbert, dei Valenti, ritirate per un momento la mano che lo sostiene e subito lo saprete. Togliete il freno della paura alla voce del vostro popolo, d’un popolo buono e fedele, d’un popolo che bacia con trasporto la polvere de’ vostri piedi, che vi stima per riflessione e v’idolatra per sentimento; abbiate il coraggio d’interrogarlo, e tutti cuori e tutte le bocche si apriranno per annunziarvi una terribile verità, che tacendo si esprime ancora meglio che favellando. Né parlo io già di quel popolo che rumina soltanto e vive senza sentire, ma parlo del popolo che ragiona ed imprime il grande suo moto alla pubblica opinione, di cui egli solo è il sovrano moderatore, all’opinione, io dico, giudice inesorabile dei monarchi egualmente che della plebe, all’opinione che governa il presente, comanda all’avvenire e non obbedisce ad alcuno. Questa parte sempre sana e sempre giusta di popolo, la cui voce è voce di Dio, egli è molto tempo che ha posta una differenza infinita tra il cuore di Ferdinando e le massime del suo ministro; egli è gran tempo che, benedicendo il cielo di possedere nell’uno de’ due un tenero padre, si addolora di soffrir nell’altro un tiranno. Né di tai sentimenti sono infiammati soltanto i petti napoletani. Essi ardono nel cuore di tutta Europa, la quale ha già registrato il nome di Acton fra gli oppressori dell’innocenza, e il nome di Ferdinando tra i prìncipi magnanimi e benefattori […] Che più? Io vi annunzio che […] la Svezia, che ha posta la mano sopra la spada per dimandarvi ragione dell’oltraggio che per conto vostro le han fatto quelli che vi tradiscono, la Svezia medesima è troppo magnanima e generosa, per non macchiare la sua vendetta colla viltà degl’insulti. Ella vuole soddisfazione, ma tale che corrisponda al sublime carattere dell’offeso e dell’offensore. Ella punirà, non dubitate, le ingiurie, ma non si abbasserà mai all’indegno sospetto di credervi consapevole o complice volontario delle medesime, che anzi spera che voi stesso punirete quando vi sarete accorto una volta dei modi iniqui co’ quali la cabala che vi circonda ha ingannata la vostra giustizia e calunniata sì crudelmente la Svezia. Su tale considerazione io desidero a questo scritto la sorte di poter penetrare in tutta la sua estensione a’ piedi del vostro trono, a cui è tempo che la verità si presenti per vendicare la vostra gloria e castigar l’impostura» (Lettera, pp. 199-204).
****(Taduzione parola per parola: Perché occorre, monsignore, che io abbia qualcosa da dirvi? Quale lingua comune possiamo noi parlare? Come possiamo intenderci? E che c’è fra voi e me? Ciò nonostante è necessario rispondervi, siete voi stesso che mi costringete. Se voi non aveste attaccato che il mio libro, io vi avrei lasciato dire: ma voi attaccate anche la mia persona).