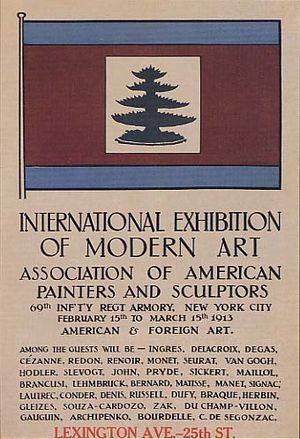FULVIA GIACOSA
Nelle grandi manifestazioni internazionali sono sempre più numerosi artisti extra-europei, nati per lo più dopo gli anni Cinquanta; appartengono ad aree diverse del globo ma operano spesso in Europa e USA dove gallerie, grandi musei e collezionisti ancora dettano legge, nonostante si siano moltiplicate un po’ ovunque le “biennali”, a Istanbul, il Cairo, Emirati Arabi, Città del Capo, Shangai, Pechino, Sud-Corea, Sidney; ma -a guardar bene- esse finiscono di conformarsi al prototipo occidentale, la Biennale di Venezia.
Già al tramonto del secolo e ancor più nel nuovo millennio si assiste ad una ibridazione che interessa tutti i continenti; spesso si tratta di persone costrette a fuggire dai propri paesi per la presenza di regimi autoritari, guerre, discriminazioni e violenze, arretratezza economico-culturale, oltre alle destabilizzazioni post-coloniali che hanno spinto gli artisti ad una ricerca di identità volta al superamento di una distorta visione da parte dell’Occidente di ciò che è “altro” e che si può riassumere nei termini ottocenteschi di “esotico” o di “primitivismo”, cosa che non aiuta certo a capire la situazione attuale, vale a dire la presenza di prospettive alternative. Altra novità è la nutrita presenza di donne rispetto al passato quando le artiste trovavano spazio nella scena internazionale sempre solo in secondo piano, mogli o compagne di artisti uomini che finivano volenti o nolenti per appannarne la figura. Lo stesso avviene nel circuito delle gallerie a dominante maschile (la coppia di galleristi Leo Castelli e Ileana Sonnabend ne è esempio), con l’illustre eccezione di Peggy Guggenheim. Si tratta spesso di figure erratiche che portano nella modernità globalizzata linguaggi e poetiche personali, libere dagli stereotipi a cui erano state relegate. Molte giovani artiste sono particolarmente sensibili ai problemi sociali a fronte di un Occidente alla deriva esistenziale e culturale; in tal senso la figura di Doris Salcedo (1958) mi sembra particolarmente significativa.
L’artista colombiana è nata a Bogotà dove ha studiato arte in Accademia. Impegnata politicamente, alla fine degli anni Settanta si reca in Nicaragua per sostiene la causa sandinista, ma proprio qui comprende che la violenza rivoluzionaria non può essere la soluzione per i paesi centro e sud-americani. La svolta esistenziale ed artistica avviene nel 1981 quando, grazie a una borsa di studio, si reca a New York dove studia scultura all’università; da qui inizia ad esporre sia nel suo paese sia in Occidente. Oggi vive tra la Colombia, gli USA e l’Europa e si autodefinisce “dislocata” perché continuamente in movimento come molti artisti dei mondi extra-occidentali. Dice a tale proposito: “La dislocazione ci consente di vedere l’altro lato della medaglia: l’indifferenza e la guerra. È chiaramente una posizione che genera conflitto e tensione, ma credo che dalla posizione di dislocazione l’arte derivi la sua espressione più potente”.
E’ considerata una delle principali artiste internazionali, vicina a quella “scultura sociale” di cui si era fatto interprete Joseph Beyus, convinto – utopisticamente – che l’arte potesse contribuire a cambiare il mondo.
Occorre ricordare la situazione catastrofica del suo paese e di tutta quell’area geo-culturale per entrare in sintonia con la sua opera: dalla guerra civile iniziata nel 1964, anno di formazione delle Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane (FARC) ai continui colpi di stato, da un tasso di corruzione altissimo complice il traffico di droga a repressioni durissime con violazioni di ogni diritto umano. Tuttavia le sue opere non narrano fatti ma da essi traggono il motivo prevalente in tutto il suo percorso: il ricordo di chi è stato vittima di violenza si trova in oggetti banali loro appartenuti, abiti, scarpe, capelli, mobili, con i quali l’artista intesse un dialogo muto, in assenza, caratteristica che la accomuna a Christian Boltanski e alle sue installazioni di abiti usati (“Personnes” a Parigi, 2010). Ai massacri del regime colombiano nel 1988 fa riferimento l’installazione della Salcedo “Untitled” del 1989, ripresa più volte fino al 1993: si tratta di semplici camicie bianche impilate ordinatamente una sull’altra e trafitte da aste di metallo, testimonianza silente di quei fatti. Nessuna figura, solo un richiamo oggettuale della loro drammatica scomparsa. Il metodo di lavoro è spiegato dall’artista stessa: esso inizia con una presa di contatto con persone che hanno subito violenze o sofferto per la perdita di familiari o amici durante la guerra civile. Spiega in un’intervista: “Quando una persona amata scompare tutto viene come impregnato della sua presenza. Ciascun oggetto, e anche ogni spazio, è un promemoria della sua assenza, come se questa fosse più forte della presenza”. Da questi incontri nascono la scelta degli oggetti e la distribuzione nello spazio espositivo. Non ha alcuna importanza che il visitatore sia a conoscenza dei fatti, ciò che conta è la forza comunicativa nel restituire il senso di perdita attraverso un linguaggio mai aggressivo bensì poetico e toccante. Un’altra serie di opere riproposte in diversi contesti e varianti ha per titolo “Unland” (a partire dal 1989): si tratta di vecchi mobili delle vittime in cui vengono colati materiali duri – cemento, piombo – atti a snaturare il loro precedente uso e creare una barriera visiva: armadi non più apribili come fossero diventati sepolcri in cui sono rimasti impigliati pezzi di tessuto degli scomparsi, letti ridotti a semplici reti-prigioni, tavoli senza commensali ormai privi d’ogni intimità domestica, sedie inaccoglienti senza schienali e diventate blocchi ingessati che richiamano interrogatori brutali. La pesantezza dei materiali utilizzati si fa metafora del “peso” di vite perdute. L’esposizione di tali lavori nella cattedrale anglicana di Liverpool (1999) si giova di uno spazio ombroso e silente in grado di amplificare, con la potenza delle immagini, il messaggio di lutto collettivo. Sullo stesso registro ma assai più intimo ed elegiaco è la serie “Atrabiliarios” del 1996, il cui titolo deriva da “atra bilis” = bile nera, malinconia: sono scarpe usurate, singole o a paia, esposte racchiuse in nicchie all’interno delle pareti e sigillate con una vescica di mucca cucita con filo chirurgico, dall’effetto sfocato che dice quanto labile sia la memoria. L’artista le aveva avute dai parenti di desaparecidos ed erano soprattutto scarpe di donne che le avevano indossate prima di sparire nel nulla. “A Flor de Piel” (2011-2014) – un “fiore di pelle” modo di dire spagnolo per indicare la reazione a forti emozioni a livello della pelle delicata e sensibile come un fiore – appare come una stoffa preziosa fatta di petali di rosa cuciti insieme con una tecnica particolare che li mantiene morbidi; ne risulta una sorta di sudario che l’artista stende sul pavimento in pieghe eleganti in memoria di un’infermiera del suo paese torturata a morte il cui cadavere non è mai stato ritrovato. Come già le suture dei famosi “Sacchi” di Alberto Burri, sono rimedi alle violenze della vita.
Il tema della scomparsa non si limita a fatti della Colombia e finisce per richiamare l’attenzione su altre brutture del mondo odierno. Qualche esempio: “Plegaria Muda” (2008-2010) presenta una serie di tavoli impilati a due a due con quello superiore rovesciato sull’inferiore che, per la forma che assumono e le dimensioni, sono come delle povere bare in legno in un ipotetico cimitero di tombe anonime e tutte uguali tra cui siamo costretti a camminare; tuttavia al loro interno e sulla terra sparsa sul pavimento spuntano fili d’erba che inducono alla speranza. La quantità dei tavoli-bare (100 in tutto) è tale da risultare sinesteticamente “assordante” nonostante il titolo parli di muta preghiera. L’installazione fa riferimento non solo a un centinaio di giovani uccisi dal regime colombiano senza apparenti ragioni ma anche a episodi di violenza tra bande giovanili dei quartieri periferici nelle città americane come Los Angeles dove l’artista ha vissuto per qualche tempo, turbata dalla ubiquità della violenza specie se gratuita. “Palimpsest” (2013-2017) ci parla di altre morti destinate a rimanere quasi sempre anonime, quelle dei migranti che perdono la vita nel disperato viaggio verso l’Europa: Salcedo, che per cinque anni ha cercato i nomi delle vittime, scrive, sulla sabbia con cui ha ricoperto il pavimento della sala, i nomi di coloro che sono stati identificati: l’installazione diventa un memoriale carico di pietas nonostante l’apparente minimalismo formale. Di quei corpi non resta nulla e il nome stesso, scritto sulla sabbia, è pronto a svanire (così come il nome degli ebrei nei campi era stato sostituito da un disumanizzante numero tatuato). Dice Salcedo: “Non credo che l’arte salverà anche solo una nuova vita o sarà di consolazione ai sopravvissuti … l’arte non può fare niente di tutto questo , però ci conferisce dignità, ci restituisce un qualche senso di umanità e di fratellanza” .
La sedia, in quanto oggetto di convivialità tra “vivi” impossibile in tempi violenti, compare spesso nell’arte di Salcedo. “Istanbul Project”, 2003, è una installazione nella vecchia Istanbul consistente in una grande massa di sedie accatastate che, inserite tra due edifici, colmano il vuoto lasciato dalla demolizione di una palazzina. In un’intervista l’artista spiega che l’accumulo di sedie era il suo monumento alla memoria delle “vittime del mondo violento” e che ogni singola sedia era “una persona”. Dunque ancora una volta l’oggetto si fa segno di una assenza. L’apparente banalità dell’installazione nel vuoto della demolizione stigmatizza i danni della speculazione edilizia indifferente nei confronti di persone che qui vivevano; l’allestimento ha richiesto non poco lavoro per trovare così tante sedie e superare la difficoltà di ammonticchiarle senza pericolo per i passanti. A tale vuoto l’arte risponde con la memoria di una socialità sempre più negletta, il tutto realizzato in una città ove a fatica convivono due continenti, due culture e due religioni (leggere Pamuk per capire Istanbul).
Infine vorrei ricordare l’opera più spettacolare e inquietante, quella realizzata nella Turbin Hall della Tate Modern di Londra nel 2007 dal titolo “Shibboleth”, tratto dall’Antico Testamento ( serviva a individuare la appartenenza ad un gruppo linguistico nemico in base alla pronuncia). L’opera è una lunga fessura a pavimento (170 metri circa) che taglia la sala principale di quella che una volta era una centrale elettrica, metafora visiva dei concetti di discriminazione e segregazione nei confronti del “diverso”. Fendere, ferire, tagliare lo spazio di uno dei più prestigiosi musei dell’Occidente è come incuneare in una cultura eurocentrica i semi di altre e finora neglette culture: non riempimento quindi dello spazio con un’opera ma svuotamento e frattura, tant’è che la critica ha parlato di “estetica della rottura”. La cicatrice profonda è un’ulteriore modalità per rappresentare una violenza che lascia il proprio “segno”. A fronte di diverse letture, Salcedo preferisce che ciascuno dei visitatori dia la propria interpretazione, pur dichiarando che all’origine del progetto c’erano le guerre del Medio-Oriente.
Vi lascio con le sue parole: “Non lavoro con il bronzo o il marmo ma con materiali ordinari. Essi vogliono mostrarvi a quale punto l’essere umano può essere fragile. Parlo della fragilità di una carezza passeggera. Se eravamo capaci di comprendere questa fragilità inerente la vita, saremo forse esseri umani migliori”.