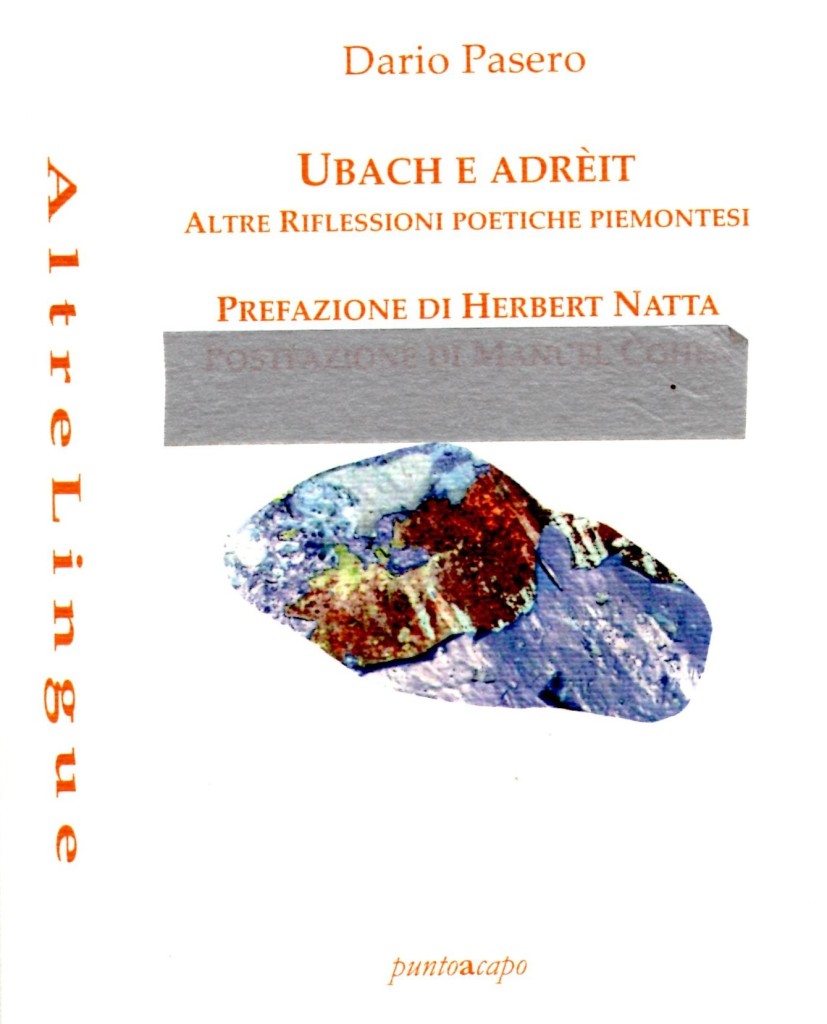NICOLA DUBERTI
Si intitola Ubach e Adrèit : altre riflessioni poetiche piemontesi la raccolta di poesie di Dario Pasero pubblicata da Puntoacapo (Pasturana, AL, 2016) che rappresenta la seconda tappa del suo nuovo cammino artistico, iniziato nel 2014 con Tèitcanaveuj. Una tappa estremamente significativa, interessantissima non solo per chi si occupa di letteratura in lingua piemontese. In effetti, la poesia di Dario Pasero – pur essendo densa di riferimenti anche topografici alla provincia di Cuneo e alla città di Torino (in particolare al quartiere di San Salvario) – non è poesia locale, poiché trasforma la realtà piemontese in una sorta di reticolo intellettuale multilinguistico e multidimensionale, capace di catturare la Storia e le storie individuali costringendole a un impietoso rispecchiamento. La lingua piemontese è in definitiva questo specchio, che a tratti diventa specchio ustorio, in cui il riverbero di illuminazioni alloglotte non incrina la terribile cristallina capacità di rispecchiare il reale. L’enciclopedica voracità intellettuale dell’autore non deve trarre in inganno: reminiscenze bibliche ed ebraiche, echi onnipresenti di antichità classica (molto più greca che romana, per la verità), barbagli di spiritualità orientale non stanno lì per distrarre il lettore o per creare atmosfere gratuitamente erudite: sono invece parte integrante di quest’attività riflettente, esercitata per naturale dote fisica dalla straordinaria lingua piemontese divenuta specchio nelle abili mani artigianali di Pasero.
Un artigianato che è in realtà arte, imparata in lunghi anni di consuetudine con l’alto magistero della filologia classica e di quella moderna, dedicata ad autori piemontesi del passato prossimo (Alfredo Nicola, Armando Mottura) e remoto (Ignazio Isler). Autore di saggi e studi sulla storia della letteratura piemontese, Dario Pasero (Torino 1952) è direttore del semestrale “L’Escalina” dopo aver insegnato per vari anni italiano e latino nel liceo classico di Ivrea.
Intervista
Il titolo Ubach e Adrèit. Altre riflessioni poetiche piemontesi è piuttosto sorprendente. Non è affatto sorprendente la coppia di contrari Ubach e Adrèit, che rappresenta una scelta estremamente azzeccata e, a mio avviso, molto evocativa. Mi sembra che il resto possa lasciare un po’ sconcertati, invece: perché riflessioni poetiche? che cosa intendi tu con questa sorta di callida iunctura? e altre rispetto a che cosa?
Comincio con la risposta alla domanda più semplice, cioè l’ultima: queste riflessioni sono “altre” semplicemente perché fanno seguito alle “Riflessioni piemontesi” contenute nel mio “primo” (tra breve spiegherò anche le virgolette…) libro di poesie piemontesi Tèit Canaveuj (del 2014). Ho detto “primo” libro, anche se in effetti è il quarto, perché in realtà è il primo (e questo dunque è il secondo) della seconda fase della mia attività poetica. Essa coincide inoltre con la scelta di pubblicare con Puntoacapo (di Pasturana, in quel di Novi Ligure), che si è mostrato un editore intelligente e sensibile ai valori della poesia (anzi, della Poesia). Anticipo che il libro a cui sto lavorando ora avrà come sottotitolo “Nuove riflessioni poetiche piemontesi”… Ma non perdiamo il filo: la callida iunctura cui tu giustamente accennavi significa semplicemente che ciò che scrivo vuole essere uno spunto (per me e per gli altri) per procedere sulla strada della conoscenza (per quanto ci è concesso…) di noi stessi e del mondo; questo è per me la poesia (la mia, ma anche quella degli altri): uno stimolo, un pungolo, uno strumento di approfondimento, che si serve però di “attrezzi” ben diversi rispetto, che so, alla filosofia, utilizzando la memoria, l’analogia, la metafora, il volo pindarico, a volte persino il nonsense… Quanto al titolo, poi, ho sempre sentito forte l’attrazione dell’ombra, alter ego della luce, ma anche simbolo del nascondimento, dell’introspezione, del “fermarsi a riposare ed a pensare”: e allora, scavando nei miei ricordi, ecco riaffiorare i tempi della valle Varaita, e dei prati all’ubach e di quelli all’adrèit.
Il libro ha una struttura molto solida, che non si rivela a una lettura superficiale ma risulta invece fondamentale per valutarne lo spessore. La prima sezione, La Manencia, raccoglie testi poetici numerati con le lettere dell’alfabeto greco minuscolo, come i libri degli antichi poemi omerici. Non sarà un caso che le poesie della sezione siano proprio 24. Tu orgogliosamente sostieni di essere uno che arriva «da la scòla dël Bòrgno», dalla scuola del Cieco. Che cosa significa per te questo richiamo ad Omero?
Omero, lo sappiamo bene, non è mai esistito e proprio in ciò risiede, paradossalmente, la sua grandezza: la sua figura è la quintessenza simbolica della poesia, è colui cha ha dischiuso la strada, camminandovi sopra (e quindi con più attenzione), gli altri si sono limitati a percorrerla con altri mezzi di trasporto (se mi passi la metafora); potremmo addirittura immaginare che senza di lui la poesia non esisterebbe. Oppure che quanto scritto dopo di lui sia solamente un riflesso della sua esperienza. C’è più poesia nel suo “a lui sorrise la dea dagli occhi glauchi” o “fortunati tuo padre e tua madre, me ben più fortunato colui che, con ricchi doni, ti porterà con sé come sposa” (quanti di noi l’hanno pensato della donna dei loro sogni…) che in quanto tutti noi sapremmo mai scrivere. Credo che sia questo che i critici intendano quando parlano di “evocativo”. Oppure (ma diciamolo sottovoce per non turbare qualche neo-critico) quello che Croce intendeva quando parlava di “poesia” contrapponendola alla “non poesia”. E poi, un laureato in filologia classica come me se non mette Omero sul suo giusto piedistallo, chi altro dovrebbe mettere? Pur ammirando e amando, intendiamoci, anche decine di altri poeti, antichi e moderni. Dopo il Contrasto di Cielo d’Alcamo il resto della poesia italiana, per quanto con molti esiti eccezionali, resta comunque sempre sul secondo gradino del podio… Ti ringrazio per questa domanda (ma anche per le altre…) perché ci permette di far capire (rebus et non verbis) che anche la poesia “dialettale” (nel nostro caso piemontese) permette di toccare argomenti “alti”.
Le quindici (più una) poesie della sezione L’apress-disné d’un faunèt è anch’essa densa di echi classici, ma si tratta di una classicità mediata dalle sue interpretazioni contemporanee: Valéry, ovviamente, e soprattutto Luigi Olivero, grandissimo poeta piemontese oggi purtroppo poco letto. Vuoi dirci qualcosa di lui? Quanto ha segnato il tuo – peraltro personalissimo – modo di fare poesia?
Olivero (1909-1996) è stata una delle mie prime scoperte quando ho cominciato ad occuparmi di poesia piemontese (circa trent’anni fa…), prima ancora di Nino Costa (tranne pochi suoi testi “classici”) e prima di Pacòt: un irregolare, estremo, eccessivo, anche se talvolta il suo andare fuori delle righe era più una posa che non una realtà (pensiamo, si parva licet, a Cecco Angiolieri), un conoscitore del mondo (grazie al suo mestiere di giornalista) e delle diverse culture e letterature, un poligrafo che scrisse moltissimo (e spesso cose non degne di ricordo) in prosa italiana, ma che tentò, appoggiandosi anche a modelli extra-italiani, di rinnovare (spesso riuscendoci) la poesia piemontese, facendole toccare argomenti prima di lui (ma anche dopo, purtroppo) tabù o comunque non “degni”, secondo la tradizione, di entrare nelle patrie lettere pedemontane. Era uno che sapeva di valere come poeta (e a volte ne approfittava), ma che sapeva anche di non essere gradito a molti (“quand i-i sarai pì nen/ as n’ancorzeran ch’i j’era”: scrisse una volta), ma che è stato indubbiamente un “caposcuola” per molti giovani (di allora, cioè anni ’70/’80) poeti piemontesi (quorum ego…). Ignorato da molti, idolatrato da alcuni, ammirato da pochi… Ecco, ciò detto, non resta molto da aggiungere sul rapporto (poetico) tra lui e me: certamente mi ha lasciato la voglia di toccare argomenti non “classici”, il desiderio di ispirarmi a poeti di estrazione (anche linguistica) differente, la curiosità di manipolare la nostra lingua poetica in modo innovativo, usando neologismi, arcaismi, forme gergali e letterarie, anche se Olivero (e in questo era figlio del suo tempo, cioè gli anni ’30-’70 del secolo scorso) indulgeva talvolta (cosa che io invece evito con cura) agli italianismi d’uso corrente (aqua per eva, tanto per fare un esempio).
Nel tuo libro c’è una bellissima sezione dedicata a San Salvario, il quartiere torinese multietnico e multireligioso per eccellenza. Si tratta, a mio avviso, di un unicum nella poesia piemontese contemporanea: la città postmoderna, in cui il piemontese è ben lontano dall’essere lingua d’uso quotidiano, viene per così dire catturata da una lingua che non ha paura di contaminarsi ma trova nel ricorso ad altre lingue lontane – l’ebraico e il russo, oltre al greco – una sorta di carburante poetico. Molto affascinante. Il piemontese secondo te ha ancora un futuro a Torino oppure lo ha solo come lingua della poesia – che già sarebbe qualcosa?
Intanto, mi spiace deluderti, ma il San Salvario presente nella mia poesia non è quello attuale, ma quello della mia infanzia e giovinezza: vi sono nato, e vissuto per i miei primi quarant’anni… quindi “multireligioso” sì (per la presenza, già allora, della sinagoga, del tempio valdese, delle chiese cattoliche, ovviamente), ma “multietnico” allora no. Tuttavia è vero che, pur rappresentando per me un “segno” personale e biografico, San Salvario già allora aveva in sé qualcosa di speciale, di diverso, rispetto ad altri quartieri torinesi; diverso dal centro storico, quartiere di passaggio (adesso si direbbe shopping e movida) e di contraddizioni abitative polarizzate (i ricchi verso il Po, gli immigrati ed i vecchi poveri torinesi in quello che ora è il “quadrilatero”), diverso da borghi operai (come Mirafiori o San Paolo) o da quartieri a lui simili, ma di lui più periferici (Vanchiglia). Già almeno vent’anni fa, parlando con amici piemontesisti, ebbi a dire “Torino è perduta” dal punto di vista linguistico, s’intende, ma io, a differenza, che so, di Gipo Farassino buonanima, che non vedeva del tutto negativamente il cambiamento, di lingua e di mentalità, di Torino, ne sono dispiaciuto. Certo, mi arrendo e prendo atto della situazione (pessima a Torino, meno grave in provincia), so che non cambierà, e mi accontento dell’uso del piemontese (da parte mia e di altri come me) come lingua letteraria, della poesia. Anzi, l’ho già detto e lo ripeto, la mia lingua scritta è esclusivamente una lingua poetica, non uso certamente questa quando parlo piemontese; in questo caso, si parva licet, mi sento in una dimensione alquanto simile a quella di Petrarca: la lingua della poesia (anche se per lui il plurilinguismo era un errore, e Contini ce lo ha spiegato bene) era tutt’altra rispetto a quella parlata; inoltre, ciò che per lui era il latino, per me potrebbe essere l’italiano, cioè la lingua essenzialmente della cultura, oltre che della comunicazione con i non piemontofoni. Ma lasciamo stare queste riflessioni se no andiamo fuori del seminato…
A fare da apparente contraltare a questo resiliente plurilinguismo, il tuo piemontese sembra voler risalire alle proprie origini, soprattutto per quanto riguarda il lessico. Anche l’uso di una forma come ubach, in cui il trattamento della consonante labiale intervocalica è quello dell’occitano, sembra indicare una direzione di recupero delle fasi più antiche e più autoctone dello sviluppo linguistico. Si tratta di una finalità coscientemente perseguita? E se sì, come si concilia con il gusto per il mistilinguismo?
Ho già detto poco fa, parlando di Olivero, e lo ripeto, che la mia lingua poetica vorrebbe essere una mescidanza di forme arcaiche (a volte, in realtà, si tratta di arcaismi relativi, poiché sono forme che ricordo usate al mio paese, dove si parlava, e spero si parli ancora, un piemontese più “arcaico”, cioè quello definito come parlé ’d pais, rispetto al torinese o alla koinè letteraria), di forme letterarie (la mia edizione critica delle poesie dell’Isler e la mia frequentazione anche di altri poeti del Settecento mi hanno aiutato molto ad acquisire forme letterarie, queste sì, veramente arcaiche, cioè non più usate – e magari anche da molti anni – neppure in campagna, dove la lingua, si sa, è sempre più conservativa che non in città), di forme gergali torinesi dei miei anni giovanili (la città è l’altra mia fonte di apprendimento linguistico), di forme provenzaleggianti usate non solo nelle valli cuneesi da me frequentate (Varaita e Maira), ma anche in alcuni paesi di fondovalle (penso al Piasco, a Verzuolo o a Dronero). A questo punto il plurilinguismo era già bell’e pronto (seppur nell’alveo limitato del piemontese) e quindi il passo volto all’inserire termini assolutamente “alloglotti”, che mi sembrassero particolarmente significativi in determinati contesti, era molto breve e poco pericoloso: e perciò l’ho fatto… Un esempio: se uso la parola tedesca Urstoff non indico solamente la “materia primordiale”, ma spero di trasportare il lettore in una dimensione che è anche filosofica e scientifica o, in altri casi, anche musicale o artistica. Per chiarire meglio faccio ancora un esempio: se voglio intendere “diesis”, devo usare la parola “diesis”, perché nessun’altra, se non una perifrasi, può sostituirsi ad essa. Così come a volte inserisco nel testo poetico interi versi tratti da poeti antichi (greci e latini), che mi sembrino evocativi ed esaustivi, in quanto mi pare che sintetizzino in modo eccezionale un concetto magari arduo da definire (per me) e da cogliere (per il lettore). E poi, anch’io, come molti di noi del resto, mi porto dietro una sorta di “maledizione” nata dal mestiere esercitato per molto tempo: chi è stato professore di liceo per quarant’anni non può, all’improvviso, liberarsi di questa sfraghìs, di questo sigillo; chiunque abbia conosciuto un professore di latino (o di italiano o di greco) sa come essi amino ricamare i loro discorsi con dotte citazioni. Il plurilinguismo e il mistilinguismo, se usati con misura e cautela, mi sembrano un modo ottimo per meglio entrare in colloquio coi lettori (così come credo abbia pensato, forse, anche padre Dante). A quest’ultimo proposito permettimi ancora una considerazione, per allontanare dai lettori di questa intervista il dubbio che il mio ego sia hors-catégorie: se cito Petrarca e Dante, non lo faccio perché mi creda a loro paragonabile, ma solo per fornire due esempi immediati e riconoscibili su cui sia possibile collocare e misurare le presenti mie riflessioni (anche se Woody Allen, a chi lo accusava di credersi Dio, rispondeva che “un modello uno lo dovrà pur avere…”). Concludendo, il nostro conterraneo Gianluigi Beccaria (monregalese, ma nato a Costigliole, nel saluzzese) dice proprio che uno scrittore ha il diritto di costruirsi una sua propria lingua, di essere talvolta oscuro se tale oscurità genera la sua opera e le è necessaria: scrivere è un invito alla trasgressione ed alla ambiguità, muoversi al limite del senso e giocare talora sul non-senso.
Tu hai intitolato Poesia una delle tue sezioni. La domanda ti sembrerà banale ma non riesco a evitare di fartela: che cos’è per te la poesia? E perché scriverla in una lingua regionale?
Anche a questa domanda credo di aver già in parte risposto; confermo comunque che la poesia è per me uno stimolo, uno spunto, un punto di partenza per avviare, attraverso armi molto specifiche e particolari, una riflessione su noi stessi e sul mondo, quello che c’è, quello passato e, perché no, anche su quello che (speriamo) verrà. Uso il piemontese perché, oltre ad essere la prima lingua che ho sentito usare, penso che la poesia piemontese (e “dialettale” in genere), oltre ai compiti precedenti, abbia anche quello di trasmettere delle notizie di tipo etnografico, linguistico, folklorico (attenzione: non folkloristico!), sociologico ed antropologico relative ad un mondo, ad una civiltà (non solo contadina, ma anche urbana: ecco allora “La Manencia” e “San Salvario”) che rischiano di scomparire per sempre non solo dalla realtà (anzi, in parte sono già scomparse) ma anche dalla fantasia e dalla memoria; se io cerco di trasmettere (e magari ci riesco) certe atmosfere, certe memorie, certi modo di vivere e di pensare, mi illudo che essi (forse) non muoiano, perché sono comunque fissati nelle parole e sulla carta (e lo stesso succede alla lingua). Aggiungo un’altra osservazione: grazie ancora una volta all’editore (ed in particolare al direttore editoriale Mauro Ferrari, che qui ringrazio) i miei libri trovano una diffusione, ancorché limitata quantitativamente (ma questo succede, credo, a molti libri di poesia, anche in italiano), comunque discretamente ampia nella “qualità” soprattutto dei lettori in quasi ogni parte d’Italia. Voglio dirlo chiaro: io trovo molto più soddisfacente essere letto, anche se con l’ausilio della traduzione italiana, da persone che ritengo sulla mia lunghezza d’onda culturale e letteraria, ancorché venete o romagnole o pugliesi (oltre che piemontesi, s’intende), piuttosto che raccattare lettori (o pseudo-lettori) tra piemontesi che la pensano solo in parte come me o che addirittura mi criticano per le mie scelte in nome di una loro personalissimamente elaborata “ortodossia” poetica subalpina.
Nella tua “ars poëtica” è sotteso un dialogo, a volte amichevolmente polemico, con gli altri poeti in lingua piemontese. Vuoi spiegare ai lettori di Margutte di che cosa si tratta?
Anche a questa domanda credo di avere, almeno in parte, già risposto, ma ora giustamente vorrei approfondire alcuni aspetti di essa. Intanto togliamo pure l’avverbio “amichevolmente”: la mia polemica è rivolta a persone che la pensano molto diversamente da me, e con le quali difficilmente potrei essere “amico” (al massimo, come si diceva una volta, “bon conossent”). Sono i piemontesi poeti, o al massimo interessati alla poesia, che hanno come “ideale” un singolo poeta “classico”, a cui consacrano tutta la loro vita ed, eventualmente, anche le loro opere (è il caso di quelle iniziali G. D. che si trovano in esergo all’Apress-disné d’un faunèt); sono i poeti delle (sia detto col massimo rispetto per queste associazioni, in alcuni casi benemerite) “Pro-loco”, che scrivono dei versi (forse sarebbe meglio dire “fanno dei versi”) in onore delle loro feste patronali o del loro paese o dei personaggi famosi delle loro contrade; sono i poeti che, come dicevo rispondendo alla domanda precedente, sono convinti che gli unici argomenti degni di essere trattati nella poesia piemontese siano le montagne, la mamma (o la nonna), il cappello alpino o, peggio, la bagna càuda e il carnevale; sono i poeti che scrivono solamente (o quasi) per i concorsi, da cui ricavare un premio o la pubblicazione delle loro opere… Mi fermo qui per carità di patria, ma si potrebbe aggiungere ancora altro: come la gente per cui la poesia “dialettale” debba pressoché per forza far ridere o essere sguaiata (per costoro, e per altri, vale la stessa convinzione anche per il teatro). Ripeto, a lettori (magari anche tanti…) di tal genere preferisco pochi lettori, ma intelligenti, il che non vuol dire che non mi critichino, ma che, qualora lo facciano, lo facciano con ragioni valide ed intelligenti, a cui rispondere con argomentazioni altrettali. Ci sono poi, per fortuna, anche i poeti piemontesi che scrivono fior di testi (diversi e spesso migliori dei miei) e con cui merita dialogare (e infatti questi sì che sono “amici”, anche se magari stiamo mesi o anni senza vederci): non faccio nomi, ma dico che sono tutti della provincia di Cuneo, uno di Torino ed uno della provincia di Vercelli. Se poi ti riferisci all’aver io citato in un mio testo Claudio Salvagno, qui non si tratta di polemica con la persona, anzi, ma con un certo modo di pensare (decisamente “radical chic”) di chi, magari sapendo poco (o anche nulla) della storia della lingua e della poesia piemontese, apprezza “a prescindere” solamente quanto è provenzale (anzi, “occitano”: ma su questo termine dovremo, magari un’altra volta, parlare un po’ più a lungo per intenderci tutti meglio…), mentre ciò che è “piemontese” appare loro, sempre “a prescindere”, inelegante, ridicolo, rozzo, ignorante, non-poetico: questo ho cercato di far capire in quel testo di cui ho appena parlato, anche perché di questo modo di pensare sono stato personalmente testimone (e vittima) anni fa…