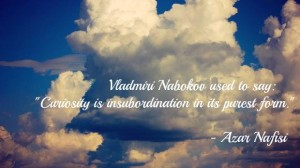SILVIA PAPI
Credo di dire un’ovvietà affermando che il grado di civiltà di un paese vada misurato prima di tutto attraverso l’osservazione del suo sistema scolastico e poi, subito conseguente, nel rapporto che intrattiene con la cultura.
Nel libro di cui sto per parlare si dice: «La vocazione del maestro è tra le più elevate che l’uomo conosca. Né la politica né la religione ci conferiscono una missione più elevata di questo precipuo mestiere di dispiegare e rafforzare le potenzialità dell’animo umano».
E inoltre: «Se i nostri figli non hanno imparato a pensare in maniera critica, non è perché vengono imbottiti di troppa poesia e storia. Al contrario, è colpa di una cultura che rende costoso e irrilevante l’accesso al pensiero libero. È colpa dei docenti stracarichi di lavoro e sottopagati, della mancanza di fondi pubblici per l’istruzione, della carenza di disciplina o di rispetto per l’apprendimento e per gli insegnanti: è colpa di una cultura troppo incentrata sui soldi, sul successo, sull’intrattenimento, sul rendere la vita più facile che significativa».
Uscito lo scorso mese di agosto per quelli di Adelphi, il libro in questione è La repubblica dell’immaginazione (Milano, 2015, pp. 288, € 19,00) della scrittrice iraniana Azar Nafisi, resa famosa a livello internazionale da Leggere Lolita a Teheran, il suo primo libro, pubblicato in traduzione italiana nel 2004.

Azar Nafisi ha insegnato letteratura anglo-americana in varie università del suo paese fino a quando le restrizioni del governo degli ayatollah non gliel’hanno impedito. Dal 1997 vive negli Stati Uniti e dal 2008 è cittadina americana.
Oggi prosegue la sua riflessione spostando l’attenzione sul rapporto che il paese che la ospita intrattiene con la libertà, domandandosi se non sia forse possibile che la letteratura occidentale si rivolga più alle anime bramose di cultura della repubblica islamica dell’Iran che agli abitanti della terra dov’è nata. Chiedendosi se non sia per caso vero che chi affronta la censura, la tortura e il carcere per poter leggere libri, ascoltare musica, guardare film e conoscere opere d’arte vede tutto questo sotto un’altra luce. È possibile che nelle democrazie il bisogno di leggere non sia poi così impellente e perché?
Dice Scout, la bambina protagonista di Il buio oltre la siepe (romanzo di Harper Lee e bellissimo film diretto da Robert Mulligan nel 1962): «Leggere non mi è mai piaciuto tanto, finché non ho avuto paura di non poterlo più fare. Non si ama respirare».
Significa che per comprendere davvero la necessità vitale di una cosa è necessario arrivare al punto di perderla?
La scrittrice fa ruotare le circa trecento pagine del libro intorno a questi interrogativi e per farlo racconta storie, quelle dei protagonisti dei testi di cui parla, che si intrecciano alla sua che a sua volta si intreccia con quella di altre persone, in un fitto legame tra storie immaginate e storie vissute che non perde mai di intensità.
Parte dall’Ottocento, alla ricerca dei fondamenti dell’identità americana che si trova proprio nel carattere meticcio della sua popolazione, magistralmente narrata in quello che spesso è considerato un classico solo per ragazzi – Huckleberry Finn di Mark Twain – in realtà romanzo epico del primo ribelle americano e ancora attuale atto d’accusa verso la nostra coscienza sociale, in quanto ben documenta come le persone cosiddette normali o perbene, ma anche gli emarginati, possano smettere di ascoltare la propria interiorità e scegliere la più facile via che adotta i peggiori pensieri e pregiudizi sanciti dalla società. Tanto che, suggerisce la Nafisi, attraverso la lettura di Huck Finn possiamo arrivare a chiederci se atrocità come lo schiavismo e l’olocausto sarebbero potute accadere senza la complicità – o cecità volontaria – di tanta gente “perbene”.
Huck è un eroe ordinario, che sa scegliere tra quello che gli viene detto di fare e quello che invece ritiene giusto – forse esempio dell’individualismo americano nella sua forma migliore – figura molto più complessa del classico cowboy solitario che arriva in città, fa fuori i cattivi e se ne va in sella al suo cavallo.
Di quanta America siamo fatti anche noi italiani? Dagli sbarchi alleati di fine guerra, alla cinematografia, alla musica, all’immigrazione, l’Italia così com’è, nel male e nel bene, è l’Italia che siamo e il mito americano, costruito su una lunga schiera di piccoli eroi, anche noi l’abbiamo guardato e in qualche misura ci ha influenzato. E se Huckberry Finn possiamo trovarlo tra i compagni che hanno formato la nostra preadolescenza, Babbit vive di riflesso in tutto quel mondo governato dal vendere e dal comprare che ha imperversato, imperversa e ora vacilla.
George Babbit è il protagonista del libro più famoso di Sinclair Lewis: il classico americano che si è fatto da sé, che ha sgobbato per arrivare dove è arrivato e che vive in un mondo governato dal business. Ha successo, una famiglia, una buona posizione sociale, ricchezza e un futuro sorridente. Ciò nonostante Babbit si chiede il perché? Perché malgrado questo si sente insoddisfatto? Domanda che lo accompagna per tutta la storia.
Dopo Twain e Lewis, attraverso autori come William Faulkner e Carson McCullers – per citarne solo due – la scrittrice cerca di ripercorrere la storia del carattere e della realtà statunitense. Ci mostra le tante facce di un mito che ormai non sta più in piedi, che traballa insieme a tutto l’Occidente, perché la crisi, che affligge anche quel paese, non è solo economica o politica, ma «qualcosa di più profondo che sta sconquassando il paese: una visione mercenaria e utilitaristica insensibile al vero benessere della gente, che taglia fuori l’immaginazione e il pensiero, che marchia come insignificante la passione per la conoscenza.[...] Tutti gli stati – anche quelli totalitari – offrono lusinghe e tentazioni. Se cediamo, il prezzo che paghiamo è il conformismo: ci abbandoniamo ai dettami del gruppo. La letteratura è un antidoto, un memento sul potere della scelta individuale. Al centro di ogni romanzo c’è una scelta compiuta da almeno uno dei protagonisti, la quale ricorda al lettore che anche lui può scegliere di essere indipendente, di opporsi alle cose che i genitori, la società o lo Stato gli dicono di fare, e seguire il debole ma essenziale palpito del suo cuore».
Con questo ottimo libro Azar Nafisi continua a portare avanti la sua battaglia in difesa del valore sovversivo della letteratura, di questa cosa meravigliosa che – come tutta l’arte, quando è vera – lascia libero il lettore di pensare e di sentire, di prendere le proprie decisioni riguardo ciò che sta leggendo. Che ci permette di osservare le storie degli altri, le loro scelte e, se vogliamo, sinceramente, porci la domanda: «E io? chi sono io?».
Viviamo in una società che tende ad anestetizzarci, a non mostrare l’interezza di un esistere fatto di gioia, dolore, vecchiaia e morte, salvo poi ridurre le atrocità più feroci a quotidiano spettacolo televisivo senza emozioni. Siamo arrivati al punto che, invece di insegnare ai giovani come nella vita non esistano luoghi sicuri, che la sicurezza è illusoria e la sola possibilità che abbiamo è vivere, sentire la vita nella sua totalità anche dolorosa – perché questo è l’unico modo col quale possiamo preservare la nostra umanità -, siamo arrivati al punto di voler mettere le avvertenze sui libri laddove si raccontano gesti di violenza (perché questo è ciò che sta accadendo nelle università americane), così che le giovani anime degli studenti non vengano turbate e possano evitare di leggere, ad esempio, quei passi di Dante troppo trucidi o quel Tolstoj troppo realistico.
In fondo censurare la letteratura o rifiutarla equivale a rifiutare il dilemma che ci accompagna e che chiamiamo vita.
L’articolo originariamente è apparso su “A rivista anarchica” n. 403 – dicembre-gennaio 2015/16 (http://www.arivista.org/)