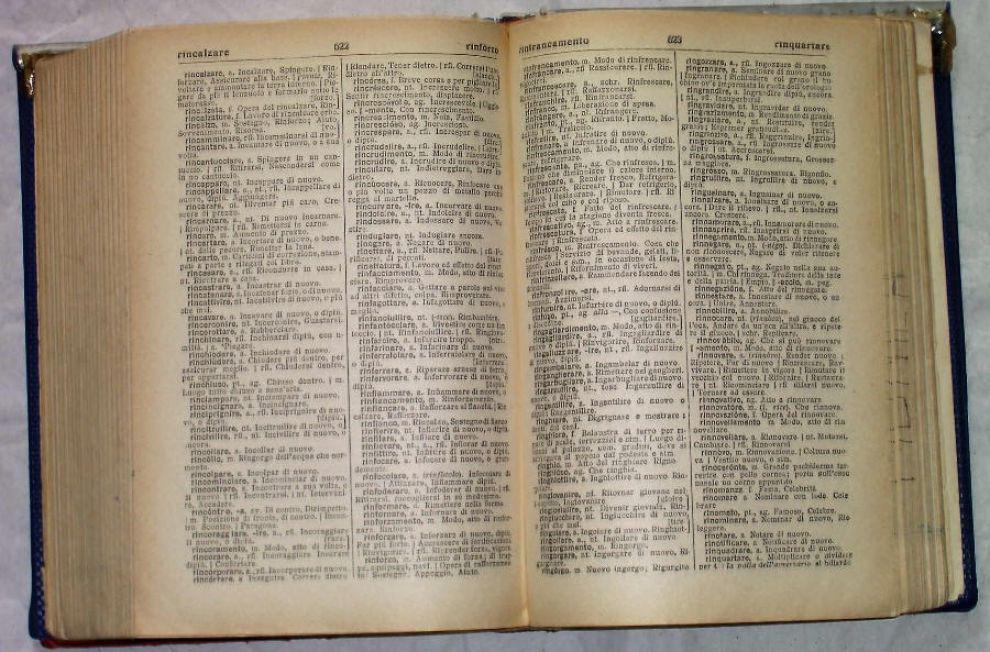STEFANO CASARINO
Doverosa premessa: chi scrive è personalmente allergico ad un modo di parlare e di scrivere :
- cauto e guardingo, timoroso di chiamare le cose col loro vero nome, pullulante di eufemismi e di litoti, com’è lo stile dei Promessi Sposi, per cui “Don Abbondio non era nato con un cuore da leone”, ecc…; sarà un esempio di encomiabile moderazione, a me è sempre parso un po’ ipocrita e molto pretesco (“sopire, chetare” ecc…);
- oppure reboante, tronfio, che trasforma le parole in petardi e si compiace di boutades e di forzature: presupposto di molta immaginifica prosa dannunziana e di tutto il retoricume patriottardo e fascista;
- oppure l’esibita debolezza e il maniacale controllo del politically correct, che smorza attenua depotenzia, per paura di offendere, per dare sempre un colpo al cerchio e un altro alla botte, in un festival di autentiche scempiaggini (“operatore ecologico”; “non vedente”; “dirigente scolastico”, “collaboratore scolastico” sono solo alcuni esempi, di diversa natura ma tutti per me accomunati dalla stessa smania pseudoperbenista.
Chiarito questo, mi piacerebbe proporre i modelli esemplari di Maupassant (per il quale non esistevano sinonimi, le parole non sono mai equivalenti, bisogna arrovellarsi a cercare ogni volta quella giusta) e di Hemingway (secondo il quale non c’è cosa più difficile che scrivere una prosa assolutamente onesta sugli esseri umani).
In nome della lotta alla retorica (e dimostrando una formidable dose di ignoranza postsessantottina), abbiamo finito per fare come dice un proverbio tedesco: abbiamo buttato via il bambino assieme all’acqua sporca!
Non si crede più che saper parlare sia frutto di studio e di fatica, chiunque si improvvisa pubblico oratore, in una sorta di gara a chi le spara più grosse e a chi più arditamente violenta il linguaggio.
È un altro frutto avvelenato dell’aver quasi del tutto eliminato la formazione classica dalle nostre scuole.
I Greci erano convinti che “parlare bene” equivaleva a “pensare bene”; facevano estrema attenzione all’uso dei termini e alla loro collocazione nel contesto.
Ci hanno insegnato la “scienza del linguaggio”, che non è affatto meno importante (anzi!) di quella della fisica o della chimica (en passant, pure esse hanno bisogno delle parole).
Ci hanno insegnato che bisogna fare molta attenzione, maneggiarle con cura, esplorarne tutte le potenzialità.
E ci hanno insegnato, anche e soprattutto, che ogni modifica del loro uso anticipa e rappresenta una modifica nella condivisione dei valori, nella visione del mondo.
A questo proposito c’è una straordinaria pagina di Tucidide (III, 82) che voglio riportare qui:
Ardeva dunque la rivolta nelle città, e quelle che più tardi si ribellavano, dopo essere venute a conoscenza di ciò che era successo, si impegnavano a superare le prime con l’immaginare nuovi pensieri o escogitare artificiosi modi per aggredire gli altri e straordinarie forme di pena.
Il consueto significato dei vocaboli che denotavano le cose lo cambiavano secondo il loro arbitrio: l’audacia sventata veniva chiamata ardente coraggio; il cauto indugio, pavida incertezza; la moderazione, simulata vigliaccheria; il prudente modo di procedere fu stigmatizzato come colpevole indolenza.
Intendendo il contrario, la stolta avventatezza era componente essenziale dell’essere valorosi; la cautela nel prendere decisioni si trasformava in comodo pretesto per non decidere alla svelta. Chi faceva sempre e comunque critiche veniva ascoltato favorevolmente; chi tentava di contraddirlo veniva guardato con sospetto; furbo chi riusciva nei propri intenti; più in gamba ancora chi tramava inganni per aver ragione del primo; chi invece si ingegnava a non ricorrere a sotterfugi meschini era considerato un distruttore della società, uno che aveva paura degli avversari.
Veniamo informati con chiarezza che nei tempi più confusi, quelli di crisi e di rivolte (Tucidide sta parlando della drammatica situazione di Corcira durante la guerra del Peloponneso) si determina prima di tutto una pericolosa confusione di parole: esse subiscono una preoccupante metamorfosi, si alterano, finiscono per indicare tutto il contrario di quello che era il loro significato originario.
Le parole hanno tutte una loro storia, sono fragili e vanno impiegate con cura: altrimenti si finisce per chiamare “eroe” chi è semplicemente “avventato”; “fautore dell’ordine” chi impiega disinvoltamente la forza; “furbo” chi è “intrigante” e via di questo passo.
La storia di ciò offre tanti esempi (“difesa dei confini” diventò “espansionismo”; “patriottismo” si mutò in “colonialismo”; col “fraterno aiuto” si inviarono i carri armati).
E sono tutti esempi di quando si è voluto, per ignoranza e/o per malafede, barare con le parole.
In che tempi viviamo oggi?
C’è chi si indigna per la mania di declinare tutto al femminile (la sindachessa, la ministra, ecc…): nelle lingue classiche esistevano gli aggettivi a due uscite, una identica per il maschile e il femminile, un’altra diversa per il neutro; noi siamo figli di quella cultura linguistica lì, probabilmente neppure più lo sappiamo, oppure sì e vogliamo comunque cambiarla. Il risultato è, francamente e almeno per me, ridicolo.
C’è , invece, chi se la prende con l’impiego di termini come “negro”, “frocio”, “checca”, ecc..: a costoro appartengo anch’io, perché ritengo che la connotazione intrinseca sia di per sé negativa.
“Negro” (diverso il discorso per “nero”) non equivale a “bianco”, basta pensarci un momento: c’è già insito del razzismo, neppure tanto criptico. Gli altri termini sono del periodo in cui l’omosessualità era comunque una devianza, quando non una malattia: mi auguro (ma non ne sono convinto) che oggi nessuno la pensi più così.
Ancora due osservazioni: come si diceva, le parole e la loro ricezione hanno una precisa evoluzione.
Quando il sottoscritto era giovane, l’impiego di un termine come “casino” era assolutamente riprovevole: oggi è tranquillamente entrato nell’uso quotidiano, e si potrebbero fare molti altri esempi. Secondariamente, bisogna tener conto anche del contesto geografico: nella regione dalla quale provengo, un termine ben noto che inizia per “b” e termina per “n” (“b…n”) viene impiegato come intercalare, magari non raffinatissimo (addirittura, un amico di mio padre lo usava raddoppiato, commettendo una spassosa anadiplosi: e questo per dare maggior forza a ciò che andava dicendo!).
Non posso non chiudere con la saggezza antica, alla quale sarebbe bene fare sempre ritorno: “Un parlare scorretto non è solo di per sé sconveniente, ma fa male all’anima” (Platone). Se ce lo ricordassimo e fossimo più rigorosi e severi con chi fa scempio delle parole, forse miglioreremmo davvero. Anche politicamente.
E per non restare sempre e solo ai Greci:
“Chiesero a Confucio: – Dove cominceresti se dovessi governare il popolo? – Rispose: – Migliorerei l’uso del linguaggio. – Gli ascoltatori furono soripresi: – Ma che c’entra con quanto ti abbiamo chiesto?- Confucio rispose: – Se il linguaggio non è preciso, ciò che si dice non è ciò che si pensa; e se ciò che si dice non è ciò che si pensa, le opere restano irrealizzate; e se non si realizzano le opere, non progredirà né la morale né l’arte; e se arte e morale non progrediranno, la giustizia non sarà giusta; e se la giustizia non sarà giusta, lo Stato non conoscerà il fondamento su cui si basa né il fine a cui tende. Non si deve tollerare perciò nessun arbitrio nell’uso delle parole. Ecco il primo e fondamentale problema”.
Appunto! Noi invece abbiamo fatto e stiamo facendo esattamente il contrario. Con le conseguenze che dolorosamente constatiamo: ponti che crollano, politici che straparlano, popolo che si inebria di slogan e di parole in libertà.
QUI l’articolo di Franco Russo
QUI la risposta di Gabriella Mongardi
QUI l’intervento di Paolo Lamberti