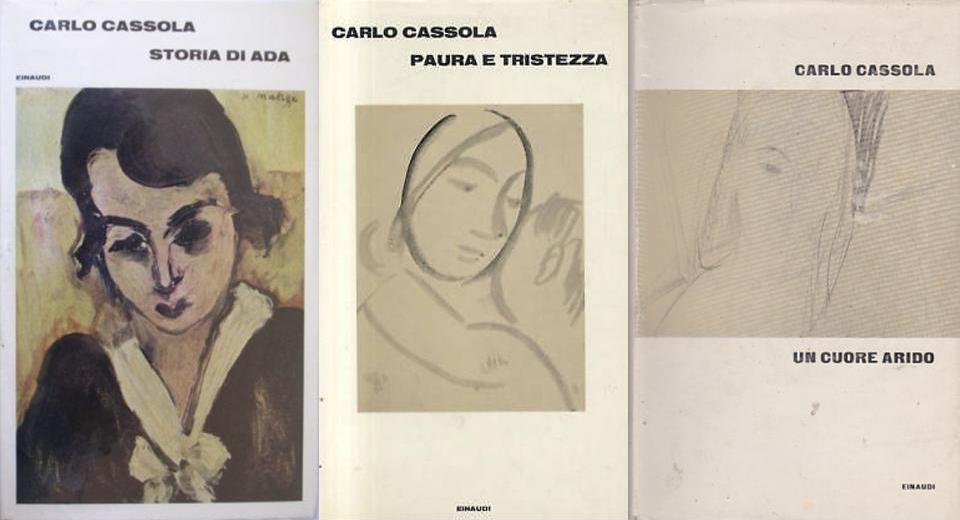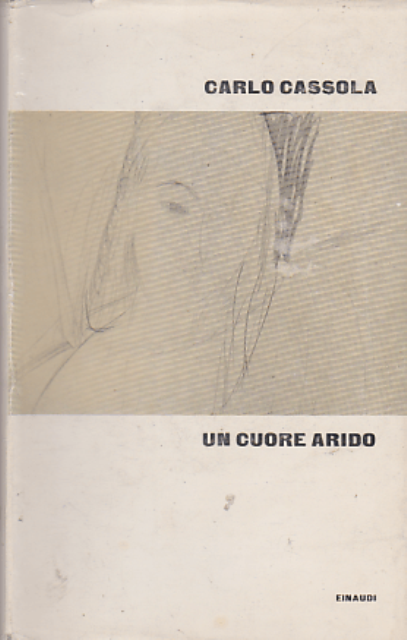GABRIELLA MONGARDI.
Avevo diciassette anni quando i miei genitori mi regalarono tre libri di Carlo Cassola: Un cuore arido (1961), Storia di Ada (1967), Paura e tristezza (1970). Tutti e tre pubblicati nei prestigiosi “Supercoralli” di Einaudi, con copertine sobrie ed elegantissime: tre ritratti di donna, rispettivamente una Figura femminile di Modigliani, un ritratto di Matisse e un disegno di Mario Marcucci. Le sopracoperte evidenziano ciò che accomuna queste opere: il fatto di ruotare tutte e tre intorno a una figura femminile. Partirò da qui per una rilettura personale di Cassola a cento anni dalla nascita e a trenta dalla morte.
Come ha scritto lui stesso in due articoli pubblicati su “La Stampa” nel dicembre del 1978, Cassola come scrittore nasce da un senso di disadattamento, di estraneità all’ambiente circostante, che però non lo porta a parlare di se stesso, ma dell’altro da sé. «Per lo meno in un primo tempo, io ero spinto a rappresentare, non già quello che avevo dentro, bensì quello che c’era fuori. E quello che c’era fuori aveva maggiore attrazione quanto più era lontano da me.»
Perciò sceglie di ambientare i suoi racconti e romanzi in Toscana, tra Cecina e Volterra, anziché nella Roma dove è nato e ha vissuto gli anni della sua formazione, fino alla prima giovinezza: perché «la vita scorre dove non si è», e lui – che si sentiva escluso dalla vita – voleva parlare della vita. Perciò sceglie delle figure femminili come protagoniste di questi tre libri: perché la donna è il polo opposto dell’uomo, e rappresenta la vita o meglio la vitalità, la capacità di aderire istintivamente alla vita, accogliere le albe e i tramonti, filtrare gli addii…
Solo una lettura frettolosa e superficiale può parlare di neorealismo – o peggio di provincialismo – per questo Cassola: il suo è semmai esistenzialismo – e classicismo.
La prima opera, Un cuore arido, è ambientata nella Toscana degli anni Trenta, tra Marina di Cecina, Cecina e Livorno, e fotografa l’affacciarsi alla vita adulta di due sorelle sarte, Anna e Bice, che cercano ciascuna la propria strada tra i pregiudizi e i condizionamenti di quella società. Bice, la sorella maggiore, è più conformista, si sottomette alla morale corrente e accetta di sposare un compaesano che non ama per ‘sistemarsi’, perché gli anni passano e “bisogna guardare anche al lato pratico delle cose”; Anna no. È lei la protagonista, è suo “il cuore arido” che dà il titolo al romanzo (o racconto lungo?): gli altri la giudicano fredda, ma lei ribatte: «Purtroppo io ce l’ho, un cuore… magari non l’avessi. Non avrei sofferto come ho sofferto». Non è certo una ribelle, una contestatrice, una che se ne vuole andare dal suo paese: ma è diversa dagli altri. Ha una sua autosufficienza interiore che la isola, la contrappone agli altri personaggi, in particolare alla sorella, e si manifesta nella sua attenzione al paesaggio, con cui è in continuo, tacito dialogo. Con il mare e con la pineta in primo luogo («Percepì il rumore del mare: quello sì che era un rumore amico, che sentiva da sempre, che avrebbe sempre sentito: senza mai stancarsene»; «Alzò gli occhi a guardare una lama di luce fra un tronco e l’altro. Quel turbinio di corpuscoli nel diaframma luminoso del raggio le ricordava un momento della sua infanzia… ma quale?»), ma anche con il cielo, con la campagna («C’era un’unica nuvola bianca e densa all’orizzonte; per il resto il cielo era perfettamente sgombro»; «Ma Anna si fermò lo stesso a guardare il fitto d’alberi e di filari, che nascondeva a metà la casa; con lo sfondo dei monti, pallidi nella serenità della sera»).
All’inizio la sua diversità si esprime nell’indifferenza all’amore, nel rifiutare il corteggiamento e le avances dei coetanei – ma quando si innamorerà l’amore la porterà a infrangere la morale sessuale imperante, a donare il suo corpo al soldato che sta per raggiungere il padre in America, senza calcoli e senza remore. La prima parte del romanzo si chiude con questa scena d’amore tra le dune della spiaggia invernale. La seconda parte si apre con un bacio dato da Anna all’amico d’infanzia innamorato di lei, che parte militare, e con il suo nuovo desiderio dell’estate «Lei si sentiva giovane, libera e desiderosa di godere […] Si sentiva libera, leggera; e tutto le pareva nuovo, benché tutto fosse consueto», ma il centro è costituito da una nuova storia d’amore con un villeggiante. Anche questa parte si chiude con una scena d’amore, in una stanza ammobiliata a Livorno: ma questa volta Anna subisce l’iniziativa dell’uomo, che in realtà non ama. Ci si potrebbe aspettare o il lieto fine (l’uomo ricco ama davvero la ragazza, ne conquista il cuore e la sposa) o la brutta fine (l’uomo si stanca dell’avventura e la ragazza disonorata deve lasciare il suo paese e mantenersi facendo il mestiere più antico del mondo), ma nella terza parte la storia evolve in tutt’altra direzione. L’estate, con l’animazione della vita notturna, non interessa più le due sorelle: Anna trova la forza di troncare la sua relazione; Bice si sposa con l’amico d’infanzia che aveva corteggiato Anna, riconoscendo il coraggio della sorella a vivere la sua vita senza tener conto delle chiacchiere della gente. Anna capisce che: «Niente, niente avrebbe potuto sconvolgere la sua vita… perché la vita, l’essenza vera della vita, era qualcosa di intangibile. Niente poteva intaccarla: e i fatti, quei fatti di cui si parla tanto, e in cui sembra che consista la vita di una persona, erano in realtà senza importanza, senza significato» e impara che: «La vita quotidiana si componeva di tante cose, piccole e grandi, rifare i letti e mangiare, fidanzarsi e sposare; ma la vita vera era come la luce e il calore del sole, qualcosa di segreto e di inafferrabile».
Il mistero della vita e il suo fascino è quello che a Cassola interessa cogliere e rappresentare: lo fa attraverso una storia “realistica”, ambientata negli anni della sua adolescenza, nella terra delle sue origini, dove trascorreva le vacanze. Realismo per lui non significa denuncia sociale né ricostruzione storica, ma narrazione oggettiva, impersonale, ‘classica’, cioè essenzialmente una scelta di stile: Cassola non è un contestatore della tradizione, uno sperimentatore esibizionista. La sua ‘rivoluzione’ è tutta interna alla lingua, che non sembra quella di un italiano, tanto è chiara e distinta, essenziale e lineare eppure increspata di commozione: frasi brevi ma non secche, prevalenza di dialoghi, grande eleganza e fluidità. E una musica sommessa, che nasce dalle cose, dall’intreccio delle voci e delle storie, e soprattutto dal paesaggio – è come la musica del mare, evocata più volte nel romanzo: «Il rumore del mare era ritmico, tranquillo: al fragore delle onde che si rompevano succedeva il fruscio dell’acqua che si ritirava».
Nel ritmo tranquillo di questa scrittura non si danno epifanie né messaggi salvifici, non si emettono giudizi né condanne, sfumano e si smussano i contrasti. Le due sorelle incarnano certo due modi antitetici di essere-al-mondo: Bice il modo irriflesso e concreto, sentimentale e socievole dell’uomo comune; Anna quello appartato, apparentemente freddo, ma autentico e profondo, dell’artista – ma i due mondi coesistono senza fratture. In questa letteratura, la vita è restituita a se stessa.
Il secondo volume, Storia di Ada, uscito esattamente cinquant’anni fa, comprende invece due racconti lunghi: quello che dà il titolo al volume e sembra il ‘prequel’ di Un cuore arido, e La maestra, in cui la protagonista è una ragazza che, avendo un diploma, occupa una posizione sociale leggermente più elevata di Anna e Ada.
Storia di Ada sembra riprendere da Un cuore arido la figura di Ada, una contadina cui la trebbiatrice aveva amputato la mano destra, per raccontare l’antefatto, ma in realtà le due storie non sono sovrapponibili, sono piuttosto variazioni sul tema. Il tema è ancora una volta quello della diversità, enunciato a chiare lettere, reiteratamente, nel primo capitolo: Ada è molto più piccola dei suoi fratelli; è chiara di carnagione e di capelli mentre loro sono scuri; è pulita e compita, pur vivendo in campagna; le piace studiare e arriva fino al diploma di quinta elementare, mentre gli altri si sono fermati alla terza: ma ciò che la rende irrimediabilmente diversa dagli altri è la disgrazia, la sua caduta sulla cinghia della trebbiatrice, all’età di undici anni.
Fin qui, la storia di Ada può essere semplicemente l’antefatto di quanto narrato da Cassola nel precedente romanzo, ma dal secondo capitolo le storie divergono e i personaggi e le situazioni, se in parte ricordano quelli di Un cuore arido, sono di fatto altra cosa. E se l’intento di Cassola è ancora quello di esprimere una sorta di “metafisica del quotidiano”, se il mezzo utilizzato è ancora la provincia, il mondo popolare, la figura femminile, la via qui additata va in direzione diametralmente opposta. Il cammino di Ada, a differenza di quello di Anna, è volto alla ricerca di una omologazione, di una cancellazione della diversità: lei prima si cerca un lavoro, poi si sposa e ha una bambina, perché vuole essere «una ragazza come le altre».
Anche il cammino della scrittura è diverso da quello del precedente romanzo breve: meno fluido, più ellittico – come se allo scrittore non interessasse tanto la costruzione di un intreccio, quanto i singoli quadri, i singoli momenti di una vita colta per lampi intermittenti, che rischiarano il buio. È come se nel primo romanzo Cassola ci avesse dato il recto, e adesso osservasse il verso della stessa medaglia: il mistero della vita, e in essa il misterioso passaggio che fa di una ragazza una donna, in grado di trasmettere la vita.
«Nulla è più stupefacente di un’esistenza comune, di un cuore semplice» aveva scritto Cassola in La visita (1942). Con questo commosso stupore, lo stupore dell’escluso, dell’estraneo, Cassola guarda la vita dal di fuori, la riduce alla sua essenza, alle sue Leggi: la nascita, la crescita, l’attrazione sessuale, la continuazione della specie, il bisogno di carezze, la ricerca della felicità, l’invecchiamento, la morte – istanze biologiche primarie, materialistiche, fondamentali, di cui noi non siamo che ‘funzioni’; e costruisce una narrazione in cui, per usare le sue parole, «il sentimento di un personaggio ha lo stesso valore del suo vestito», in cui tutti gli elementi vengono accostati paratatticamente sullo stesso piano, senza gerarchie.
Queste Leggi vengono confermate nell’altro racconto lungo del volume, La maestra, che però ‘fotografa’ un momento successivo dell’esistenza, il superamento della linea d’ombra tra adolescenza e vita adulta, la presa di coscienza che “i giochi sono fatti”. A sottolineare questo cambiamento di prospettiva, questo slittamento di interesse, sono le mutate coordinate narrative: il racconto è ambientato nel Volterrano, non più in riva al mare; la vicenda si colloca nel secondo dopoguerra, non più negli anni ’30; la protagonista, Fiorella, è una donna già sposata, con due bambini e un lavoro che le garantisce un’indipendenza economica, per quanto minima.
Anche qui la trama è minimalista: il racconto inizia con l’arrivo della maestra nel paesino di Metato e si conclude con il suo trasferimento a San Vincenzo, ma stranamente non si parla quasi mai di scuola. Cassola mette in luce le condizioni di povertà in cui Fiorella vive, i suoi rapporti con i compaesani e con il marito, da cui di fatto è separata, l’incontro con il medico condotto, con cui intreccerà una relazione, ma soprattutto la campagna e l’essenzialità della vita in campagna. «Di notte la campagna aveva qualcosa di solenne. Come se con il favore delle tenebre riacquistasse quella maestà che gli uomini non sono più disposti a riconoscerle. Un semplice cespuglio sull’argine pareva un gruppo d’alberi; una casa subito sopra la strada torreggiava come un castello. Anche i paesi, rompendo il buio con le cascate di lumicini tremolanti, affermavano il loro diritto a esistere, a sopravvivere. “In fondo, che abbiamo di meno qui? – pensava Fiorella. – Che ci manca? Le stupidaggini; ma le cose essenziali, sono le stesse dappertutto”.»
Fiorella assomiglia ad Anna di Un cuore arido nel suo aspirare a una vita indipendente, nel suo non perdersi d’animo, nel suo rapporto con la natura, o meglio con il paesaggio toscano, un paesaggio via via più familiare, che «perde quel che di triste, di angoscioso che hanno i posti nuovi» – un paesaggio collinare di cui Cassola coglie con sensibilità straordinaria non solo la profondità e la varietà, ma soprattutto il suo mutare a seconda dei giochi di luce e d’ombra, del punto di osservazione, delle stagioni: un paesaggio che diventa per questo emblema dell’irraggiungibile, senza però perdere nulla della sua concretezza ‘geografica’.
È nella contemplazione del paesaggio, attraverso il dialogo interiore con esso, che Fiorella acquista consapevolezza di sé e della vita. Lei, che nello spazio ama ciò che è lontano («A scuola la sua materia preferita era la Geografia»), che appena può esce a fare una passeggiata fino a una località chiamata la Veduta per guardare, lontano, i campi e i paesi sparpagliati nel fondovalle, il profilo di Volterra, i boschi, i filari di viti, un torrente ridotto a pozze che luccicano al sole, i poggi che culminano nel monte Voltrajo, nel tempo non si spinge oltre il presente («Solo il presente contava»), non fa progetti, sapendo che «la vita è un caso», e che «le cose belle, quelle a cui veramente aspira la nostra anima… sono al di là di qualcosa, c’è sempre un muro tra loro e noi». Eppure quel paesaggio sembra dischiudere un’altra possibilità, o meglio la Possibilità: «Aveva il suo cammino tracciato, non poteva più prendere un’altra strada. […] Invece quegli alberi, quel cielo lontano chiamavano a una vita diversa ».
Al di sotto del realismo, un realismo sobrio e commosso insieme, Cassola racconta sì il superamento della linea d’ombra, il passaggio – per dirla con Kierkegaard – dallo stadio estetico allo stadio etico dell’esistenza, dal regno adolescenziale dell’et-et, della non-scelta, al mondo adulto dell’aut-aut, del prendere una ‘forma’ rinunciando a tutte le altre alternative possibili, ma contemporaneamente annuncia che quel passaggio non cancella «gli echi di una vita tumultuosa, piena di imprevisto e di avventura», che restano comunque percepibili da chi è diverso, da chi custodisce intatta la propria dignità e libertà interiore, come Fiorella…
È la Possibilità quello che costituisce il fascino profondo del vivere, è la Possibilità che l’Arte costantemente insegue e tenta di rappresentare: non importa quanto siano rigidi in apparenza i binari su cui scorre la vita, il Possibile è sempre in attesa, è la dimensione artistica: come per Montale, anche per Cassola un giorno da un malchiuso portone / tra gli alberi di una corte / ci si mostrano i gialli dei limoni…
Anche il romanzo Paura e tristezza, uscito nel1970, è ambientato a Volterra e nel volterrano, come La maestra, ma cronologicamente si ritorna ai primi del ’900, agli anni della prima guerra mondiale e del primo dopoguerra, anche se i riferimenti storici non sono mai espliciti. La protagonista si chiama di nuovo Anna, come in Un cuore arido, e con la sua omonima ha in comune la sensibilità per il paesaggio, quello della campagna toscana tutto punteggiato di ulivi, viti, coltivi, poderi, borghi, un paesaggio solcato dal vento, che cambia con il mutare delle stagioni e pure rimane sempre lo stesso, un paesaggio rassicurante, amico, anche se dietro le siepi, tra le macchie, si possono fare brutti incontri – ma non è colpa delle colline…
Naturalmente, data la maggiore ampiezza della forma-romanzo, la storia si sviluppa per un più lungo arco di tempo, la protagonista viene seguita dall’infanzia… fino all’infanzia dei suoi figli, nei due snodi cruciali dell’esistenza: il passaggio dall’infanzia all’adolescenza e da questa all’età adulta, attraverso l’esperienza del sesso, un’esperienza sentita come vergognosa, inspiegabile, fatale.
Il testo, suddiviso in tre parti, è scandito da nove capitoli, tutti contrassegnati da un titolo come se fossero dei racconti autonomi, e il romanzo sembra una catena di racconti, ha la leggerezza del racconto. Fra le tre parti del romanzo, fra un capitolo e l’altro, fra i paragrafi all’interno dei capitoli la scrittura ellittica di Cassola – harena sine calce – spalanca delle voragini: come già in Storia di Ada, anche qui la narrazione procede per quadri, l’azione è ridotta al minimo, perché quello che interessa allo scrittore non sono eventi drammatici, catastrofi, colpi di scena, ma la quotidianità dell’esistenza, il suo nudo scorrere, la concatenazione dei giorni e delle stagioni e ciò che appena appena la increspa: un incontro, uno screzio, la fatica del lavoro, il riposo della sera…
Per questo continua ad ambientare le sue storie tra gli ‘umili’, donne sole che vivono in condizioni di povertà estrema ma dignitosa, in un tessuto sociale oscillante tra ostilità e solidarietà: per rappresentare il ‘grado zero’ del vivere, l’essenzialità dell’esistere come essere-per-la-morte, tolte tutte le ‘sovrastrutture’ che lo maschererebbero, lo altererebbero – in primis la ricchezza, con cui l’uomo si illude di diventare immortale… Il tema viene enunciato, con la voce di Anna, già alla fine del primo capitolo: «Era triste il mondo, c’erano per tutti l’infelicità e la morte. Perché, o si moriva noi, o morivano gli esseri che c’erano cari», e così si capisce inequivocabilmente da dove nasca la tristezza che compare nel titolo del romanzo. L’altro sentimento indicato nel titolo, la paura, è invece paura della solitudine per Anna bambina, e paura di brutti incontri per Anna ragazza, ossia paura dell’amore. «L’amore era una trappola», «Non si poteva stare così sempre, senza rispondere alle chiamate della vita?»: perché l’amore segna l’ingresso nella vita adulta, significa essere cresciuti, andare incontro alla morte…
Eppure, nonostante il titolo, Paura e tristezza non è un libro cupo, e la protagonista conosce anche momenti di felicità, perché – come le altre eroine di Cassola – sa vivere nel presente e sa guardare, ascoltare, godere la natura. Soprattutto, sa di essere dentro la vita – e sa che basta questo per sentirsi felici, anche se «purtroppo la felicità non c’è»: basta avere sul viso un riflesso di quella luce, «la luce dolce, calda, affettuosa» che, verso la fine del romanzo, nel momento più drammatico per Anna, illumina al tramonto la parete delle Balze, sotto Volterra.
Quella luce “dolce, calda, affettuosa” in realtà illumina tutto il romanzo: è la luce dello sguardo che il narratore posa su quel mondo, l’oggettivazione del suo atteggiamento tutt’altro che impassibile, bensì commosso, affettuoso, partecipe: ne è prova il suo assumere sempre il punto di vista di Anna, quasi in una sorta di identificazione, di proiezione sul personaggio. Questa è la ragione profonda per cui Paura e tristezza non è un libro cupo, e neanche un libro rassegnato: perché il narratore – come Anna – sa vedere la vita che brulica e che solitamente non si vede e ne ama l’enigmatica bellezza, di cui è emblema la bellezza del paesaggio.
Il sentimento del paesaggio e della natura ricorda il Pascoli di Myricae, addirittura si potrebbe definire Paura e tristezza la versione in prosa di testi pascoliani celeberrimi come Arano o Lavandare (la madre di Anna fa la lavandaia…): lo stesso amore per la campagna, natura a misura d’uomo, la stessa poesia delle piccole cose, lo stesso senso di abbandono. Quasi ogni pagina del romanzo trabocca dei suoni, dei colori, dei profumi, delle forme del paesaggio toscano, che relegano in secondo piano la storia: la prima guerra mondiale rimane sullo sfondo, è percepita solo per le sue ripercussioni sociali – l’arrivo dei profughi, la partenza degli uomini per il fronte – che rendono ancora più precaria la vita della piccola comunità. È il paesaggio con il suo mutare dovuto all’avvicendarsi delle stagioni a segnare il ciclico scorrere del tempo naturale: la storia si apre in una radiosa giornata di primavera, con i peschi in fiore («Vaporoso com’era, quel rosa sembrava far parte dell’aria più che della vegetazione») e termina, un numero imprecisato di anni dopo, con il rassicurante ritorno dell’autunno: «Per un momento Anna si sentì contenta, come le succedeva sempre da bambina, quando il principio dell’autunno voleva dire andare a vendemmiare da Ersilia, andare con la mamma a raccattare le castagne, e ricominciare ad andare a scuola».
Eppure il paesaggio non ha nulla di idillico, di oleografico, alla maniera di Fucini, non ha nulla nemmeno di intellettualistico, di allegorico. Il realismo di Cassola si traduce in una profonda aderenza alle cose, nel tentativo di varcare la soglia “oltre la quale l’aspetto consueto e frusto delle cose coincide con l’epifania della loro verità più intima” (Matteo Marchesini) e fa pensare all’arte di Morandi: un’arte ascetica, che fa coincidere quotidianità e astrazione, un’arte che più si concentra su toni sommessi e scoloriti, più tende verso qualcosa di assoluto – che per uno scrittore non può che essere la Scrittura.
Una scrittura decisamente anacronistica, controcorrente rispetto alle tendenze dominanti dell’epoca, dal pastiche di Gadda all’avanguardismo del “Gruppo 63”. Un italiano con realistiche venature toscane, termini gergali, settoriali, ma estremamente elegante e sobrio, classico e misurato, lievitato da una musica sommessa e discreta. Una lingua che conferma come per Cassola la letteratura non debba riprodurre il reale ed edificarsi su documenti storici, men che meno essere engagée: lui sa bene che «nell’arte l’unica realtà è l’arte» (Paul Valéry), che l’arte è verità sì, ma «verità sull’artista» (Thomas Mann).
Non è che sia illecito parlare per questo romanzo di “realismo storico”: l’autore finisce con il rendere anche testimonianza a una forma di esistenza, a una civiltà rurale che prima la Seconda Guerra Mondiale e poi il miracolo economico degli anni ’60 avevano di fatto spazzato via, ma gli si farebbe torto se ci si fermasse a questo piano, sarebbe una lettura riduttiva. La verità più profonda di Cassola, il fascino di queste tre opere risiede nella loro spoglia esistenzialità, nello sguardo che non mistifica, nel chiamare le cose con il loro nome.