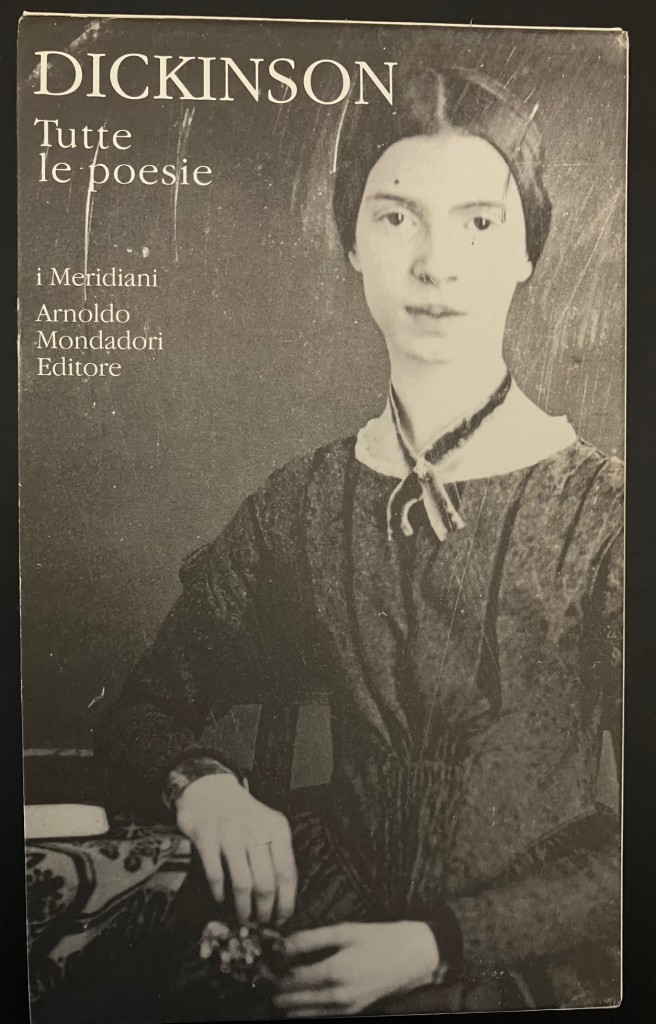ANNA STELLA SCERBO
La poesia accoglie in sé la realtà, anche quella vissuta solamente nello spazio della propria interiorità; uccide la morte e salva la speranza; esplora la natura con lo stesso amore compiuto con cui esplora il cuore dell’uomo. Anche quando vive nella clandestinità e si alimenta di silenzio e esclude da sé il mondo esterno. Emily Dickinson ha vissuto di poesia, ne ha fatto la propria stella polare, l’unica ragione per cui vivere.
Personalità affascinante la sua, antagonista solitaria e sensibile di una società oppressiva e monotona. Nel Massachusetts di metà ottocento l’educazione seguiva regole severe e puritane. Emily ne soffriva, ma non fu con gesti eclatanti o con affermazioni libertarie che rivendicò e ottenne la propria libertà. Nel 1861 la Dickinson si autorecluse nella propria stanza. Perennemente vestita di bianco trovò lo spazio vitale nella sua poesia, la possibilità di penetrare in un cosmo totale dentro ad una dimensione che da fisica si trasformava in anelito metafisico. L’isolamento volontario fu dettato da un bisogno dello spirito, da una sensibilità concentrata sul proprio io e sulle proprie ragioni. Delle 1775 poesie composte in quell’isolamento, solo sette furono pubblicate in vita. Alla sua morte, la sorella Vinnie scoprì i versi nascosti in un contenitore dove erano stati custoditi in fogli piegati e accuratamente cuciti con del filo. Pubblicati, ottennero nel corso del tempo un sempre maggiore successo.
La poesia di Emily Dickinson è un materiale in continuo movimento ed è la lingua a trascinarla, a invitarla a ruolo di oracolo, a parlare in lei. In questo processo di creazione la “parola” assume l’importanza di qualcosa da contemplare – “Non conosco nulla al mondo che abbia il potere della parola […] A volte ne scrivo una e la guardo fino a quando non comincia a splendere e non c’è zaffiro che possa eguagliarne la luce”- La parola salda gli spazi tra un mondo fatto di piccoli gesti quotidiani e di superbe aspirazioni verso il Divino realizzando un unico spazio dove le immagini fisiche diventano simboli e metafore: “I Monti – crescono inavvertiti -/i loro fianchi di porpora si erigono/senza sforzo – o stanchezza -[…] Nei loro volti eterni/il Sole – esultando sereno/cerca con sguardo lungo – estremo – d’oro – compagnia – per la notte”.
La sua poesia non ha alcuna progettualità letteraria e volontariamente trasgredisce le usate codificazioni linguistiche. Frequenti sono le anomalie ritmiche, grafiche e anche grammaticali; la disobbedienza formale del suo linguaggio crea una poesia originalissima, la più grande nell’America del diciannovesimo secolo.
L’impressione è quella di trovarsi di fronte ad un io lirico che cambia nella propria omogeneità, che assume ruoli diversi quasi in un teatro elisabettiano o che si propone inafferrabile a volte e per questo si avvicina alla lezione di Shakespeare e di Dante. La lente della Dickinson opera sul reale: ingrandisce e rimpicciolisce le immagini come su una “pellicola poetica”; scava nel sottosuolo della coscienza, nel continente inesplorato del sé, mai appagata ma mai sconfitta o stanca della stessa inesauribile sete dell’infinito mondo che abita la sua vita di solitaria: “Ci sono due specie di maturazione -/visibile la prima,/le cui forze celestiali s’insinuano/ finché il frutto vellutato cade/[…] La seconda è più intima,/Un processo nel riccio/della castagna”.
In un universo femminile che si muove alla ricerca di un codice di interpretazione di sé e del mondo, che sogna la propria affermazione oltre le costrizioni e le convenzioni della propria epoca la poesia della Dickinson riscrive le regole dell’essere donna e mantiene modernissima e attuale la sua voce che accompagna gli oggetti e i sentimenti dal finito all’infinito.
Lo fa con le piccole cose di ogni giorno: “Quattro alberi su un campo solitario/senza un progetto, o un ordine,/o un’azione apparente,/se ne stanno lì /Il sole li saluta ogni mattina,/e anche il vento./Il loro vicino più prossimo /è Dio”.
Lo fa annunciando la propria solitudine abitata dalle creature della sua immaginazione e del suo spirito: “Sola non posso stare -/mi vengono a trovare/ospiti che eludono chiave/ e registrazione-[…] Il loro arrivo è annunciato/da corrieri interiori -/ma la partenza è ignota/ infatti non sono mai partiti”.
Lo fa cantando dell’amore che è tentativo di sconfitta del tempo e mezzo di elevazione: “Se fossi certa, dopo questa vita,/che la tua e la mia saranno ancora,/la scaglierei, come una scorza vana, e prenderei l’Eterno”.
Lo fa invocando, nel “non luogo” della sua coscienza, la Libertà per la quale si è chiusa al mondo e alla storia: “Le sbarre non stridono più amare/sull’uomo che fu libero -/[…] Dio dei Ceppi/ Dio dei liberi -/Non mi rubare /la Libertà”.
Lo fa infine, dichiarando la funzione dei poeti il cui ruolo è esattamente scritto nel lascito dei suoi versi, vitali e ontologici, mortali e metafisici, sperimentazione mai appagata, mai pienamente raggiunta del Divino nell’umano: “Accendere una lampada/e sparire/Questo fanno i poeti/ma le scintille /che hanno ravvivato/se vivida è la luce/durano come i Soli”.
SCERBO ANNA STELLA, Marcellinara (CZ)
Passioni: Fotografia-Natura- Poesia-Scrittura
Categoria lavorativa : Pensionata in carriera-In un passato non lontano “attivatrice” di energie intellettuali e interiori. (Da leggersi, docente)
Articolo pubblicato originariamente il 6 ottobre 2013